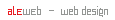Documenti generali Santa Maria della Misericordia - Correggio
Analisi storica
 leggi o scarica il documento
leggi o scarica il documento
 leggi o scarica il documento
leggi o scarica il documento
CAPITOLO PRIMO - Inquadramento storico
CAPITOLO PRIMO
INQUADRAMENTO STORICO
1.1 La Confraternita di Santa Maria della Misericordia in Correggio
1.1.1 Dalle origini del sodalizio alla soppressione ducale
Fra le numerose confraternite correggesi quella di Santa Maria della Misericordia è certamente la più antica benché, ad oggi, non si conosca la data di erezione. Rombaldi 1, ritiene fosse in attività "fin dal 1316" e correttamente relaziona la sua nascita con il movimento dei "flagellanti" che si diffuse in tutta Europa a seguito delle grandi pestilenze del Basso Medioevo.
Non a caso, come riporta Corradini nel suo studio sulla confraternita 2, le più antiche intitolazioni presenti nei documenti parlano di Hospitale Verberatorum de Corigia, oppure di Hospitale Sancte Mariæ Verberatorum in castro Corigia. Scarse, però, sono le fonti risalenti al XIV secolo, come pressoché inesistenti sono le informazioni sulla vita religiosa e caritativa del sodalizio nei suoi primi due secoli di vita. Sul finire del Trecento la confraternita era retta da due amministratori, ai quali, nel secolo successivo, sarà dato il nome di massari. Fedele al messaggio evangelico di fraternità, il sodalizio raccoglieva fra le sue fila aristocratici, notabili ma anche artigiani e gente umile, tutti profondamente mossi da una mistica tensione per la salvezza della propria anima, concretizzata nella preghiera comune, nelle celebrazioni di suffragio per i confratelli e per i benefattori defunti, oltre che nelle opere di misericordia, quali il conforto ai condannati "a morte", il soccorso degli indigenti e il sostentamento dell'infanzia abbandonata. Anticamente retta da un massaro, nel 1490, la confraternita riformò i propri statuti dotandosi di un priore e di un sindaco (vice-priore), assistiti da un massaro e da un fattore. Il carattere laicale dell'istituzione fu rimarcato dall'obbligo di eleggere gli ufficiali (priore, sindaco, massaro e fattore) fra i confratelli laici, escludendo quindi i membri del clero che venivano accettati nella congrega in veste di cappellani, necessari per la cura del culto e l'espletamento degli obblighi di suffragio del sodalizio.
Verso la metà del Cinquecento, per far fronte alla grande mole di lavoro che impegnava la confraternita, si decise di scorporare l'amministrazione in quattro parti.
Al priore fu affidato il compito di sovrintendere ai redditi derivanti dai beni immobili e dagli interessi fruttiferi oltre alla conduzione ordinaria della confraternita, al sindaco la gestione delle
1 Odoardo Rombaldi, Correggio Città e Principato, pp. 163-64.
2 Corrado Corradini, Per una storia delle confraternite laicali a Correggio - inventario dell'archivio di San Sebastiano e di Santa Maria della Misericordia, in Strenna Pio Istituto Artigianelli, Reggio Emilia 1988, p. 124.
spese correnti, al massaro l'amministrazione delle rendite derivanti dai servizi funebri che il sodalizio svolgeva, ed infine, al fattore fu affidata la cura degli esposti.
Un quadro generico dell'attività della confraternita, nella prima metà del Quattrocento, è fornito dalla Visita pastorale all'ospitale di Santa Maria in Borgovecchio, compiuta l'8 luglio 1439 da Francesco Fogliani, vicario generale della diocesi, per conto di monsignor Massolini vescovo di Reggio 3. Leggendo la relazione allegata emerge che la confraternita disponeva di una chiesa (contigua all'ospedale) dotata di tutte le suppellettili liturgiche al pari della altre chiese cittadine; il massaro, Francesco Frigeri, da quattro anni alla guida del sodalizio, viene indicato essere a perfetta conoscenza dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ospedale e in grado di garantire l'assistenza agli indigenti. Dunque una realtà stabile, ben inserita nel contesto sociale cittadino, tanto da estendere la propria opera a tutto il territorio della contea correggese.
A partire dalla metà del Trecento, numerosi lasciti avevano dotato la confraternita di terreni e abitazioni a Correggio, nelle ville di Mandrio, Rio, San Martino piccolo e Fazzano, e al Castellazzo di Campagnola, originando un cospicuo patrimonio indispensabile per il sostentamento dell'ospedale.
Il progressivo affermarsi nella vita correggese della confraternita della Misericordia, andò di pari passo con il consolidarsi del potere dei da Correggio sulla città; svanito il sogno di costruire un feudo unitario che inglobasse Parma, Guastalla e Castelnuovo Sotto, la Signoria decise di concentrale la propria azione politica e culturale su Correggio e sui territori circostanti 4.
Ne conseguì un forte impulso all'espansione della città, che comportò una riorganizzazione di tutto il tessuto urbano. Tra il 1360 e il 1380, Correggio fu cinta da una nuove mura, inglobando il quartiere del Borgovecchio, sorto un secolo prima a seguito dell'inurbamento delle popolazioni del contado.
Cuore pulsante della vita economica cittadina, il borgo era abitato da artigiani, conciatori di pelli, piccoli mercanti, vinai e osti, persone per lo più estranee alla vita pubblica della Correggio del Quattrocento che trovava in altri quartieri la sede per le proprie istituzioni.
Grazie alla sua posizione baricentrica e alla vicinanza con la porta di Santa Maria, l'ospedale divenne il principale polo di aggregazione del Borgovecchio tanto da trasformare la chiesa di Santa Maria della Misericordia da oratorio confraternale a chiesa di quartiere. Pur restando formalmente alle dipendenze dalla prevostura di San Quirino, alla quale spettava anche la nomina del rettore di Santa Maria, i fedeli del borgo si caratterizzarono per il culto alla Vergine, tanto da ospitare per
3 Archivio Memorie Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43, Origine della confraternita di Santa Maria. Si tratta della più antica visita pastorale alla confraternita della Misericordia di cui sia rimasta traccia documentaria.
4 Crf. Corrado Corradini, Per una storia .,cit., p. 125. Come scrive Corradini: "il fatto di trovare nel 1371 alla guida della confraternita una personalità come Guido Mondestri, rettore della chiesa di San Quirino, commendatario della chiesa di San Donnino di Fazzano ed appartenente ad una famiglia del contado dotata di prestigio politico, legata ai Da Correggio, è indice di un attento interesse con cui a Correggio si guardava al cresciuto ruolo della confraternita."
secoli l'unica chiesa cittadina dedicata alla Madonna5.
Per tutto il Quattrocento crebbe l'importanza della confraternita tanto che, nel 1490, con bolla del protonotario apostolico Luigi Capri, luogotenente generale del cardinale Ascanio Maria Sforza Visconti, Legato pontificio di Bologna, fu annesso all'Ospitale di Santa Maria della Misericordia, quello di San Bartolomeo, posto in prossimità del Ponte Mainardo nella villa di Fazzano6. L'annessione segnò un punto di svolta, non solo nell'attività assistenziale, aumentando il numero di indigenti soccorsi ma anche sotto l'aspetto devozionale, affiancando al culto della Vergine quello di san Bartolomeo apostolo, festeggiato ogni anno la mattina del 24 agosto con due Messe solenni, una in Santa Maria della Misericordia l'altra nell'omonimo oratorio, precedute da un triduo di preparazione. Anche la venerazione per san Giovanni Battista, patrono dei condannati a morte e dell'infanzia abbandonata, si era imposta nel corso del Quattrocento, probabilmente a seguito di un legato testamentario.
In questo clima di fervore religioso e di cristiana carità, nacque, si formò e visse Antonio Allegri detto il Correggio, membro di una delle tante famiglie mercantili e artigiane del Borgovecchio. Benché non sia provata una sua diretta adesione alla confraternita della Misericordia, mentre altri membri della famiglia Allegri compaiono fra i beneficiari dei suffragi di San Sebastiano7, è indubbio il legame che unì il Correggio alla chiesa di Santa Maria che, grazie ad una serie di fortuite coincidenze, fu il tempio correggese ad ospitare il maggior numero di sue opere. Verso la metà del Cinquecento, a seguito di nuovi flussi migratori provenienti dalle campagne, la densità del nucleo urbano crebbe ulteriormente, costringendo la confraternita a fronteggiare le numerose richieste di soccorso. La partecipazione delle più illustri famiglie di Correggio alla vita della confraternita, a partire dai da Correggio, fu un elemento fondamentale per la realizzazione delle opere del sodalizio, tanto che l'istituzione di legati e cappellanie continuò per tutto il Cinquecento e per gran parte del Seicento, manifesto segno di affezione dei ceti più abbienti alla Misericordia.
5 Crf. Corrado Corradini, Per una storia .,cit., p. 124-25.
6 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 44. Il culto a san Bartolomeo Apostolo, unitamente a quello per san Tommaso Becket fu introdotto nel 1176 dalla signoria dei da Correggio che avevano fatto dono ai sacerdoti della chiesa castrense di San Michele Arcangelo e Quirino di un terreno, sito in località ponte Mainardo, perché questi vi erigessero una chiesa ed un ospedale dedicati ai santi Bartolomeo Apostolo, Tommaso Becket e Quirino Vescovo. Crf Girolamo Tiraboschi, Memorie storiche modenesi col Codice Diplomatico modenese, III, Modena 1794, doc. n° CCCCLXVII, pp. 62-63, la costruzione dell'ospitale è erroneamente attribuita al 1173, mentre secondo gli studi effettuati da Corradini, è da posdatare al 1176 (vedi C. Corradini, Un culto in età moderna: la Madonna della Rosa di Correggio, in Ravennatensia XII, Atti del convegno di Fidenza 1983, Cesena 1989, p. 180).
7 Valter Pratissoli, I fratelli dalla cappa turchina: La Confraternita di San Sebastiano in Correggio edito dalla stessa confraternita nel novembre 1996. p. 25. Pratissoli scrive in notazione che i suddetti dati si ricavano ad annum da: Archivio Memorie Patrie, cartella 87, Libro di conti de le entrate di S.to Sebastiano e S.to Roccho administrate per me Iacopo Balbo et me Hieronimo di Silvestro Zuchardo (1541 e seguenti) e dall'Archivio Opere Pie, cartella 36, Libro dei conti dé massari della Confraternita di S. Sebastiano dal 1502 al 1637, conservati presso la Biblioteca comunale di Correggio (titolo apposto dall'archivista Cafarri).
Con Breve pontificio datato 23 marzo 1583 la confraternita ottenne l'aggregazione all'Arciconfraternita del Gonfalone di Roma8 che, oltre a valere come riconferma dell'erezione canonica, ne consolidò l'indipendenza dall'ordinario diocesano e aumentò il numero di indulgenze a disposizione del sodalizio correggese verso le quali indirizzare i bisogni spirituali degli affiliati e dei benefattori. In ossequio allo spirito del sodalizio che voleva tutti i membri "figli uguali" dinnanzi alla Madre Celeste, l'abito dei confratelli prevedeva, oltre alla cappa, il cappuccio; molto più di un semplice retaggio del passato di "battuti", il volto coperto era espressione dell'anonimato della carità e l'annullamento della vanità umana. A seguito di una disputa con le confraternite di San Sebastiano e della SS.ma Trinità attive in città nei medesimi ambiti caritatevoli, nel 1623 il vicario generale della diocesi, obbligò la confraternita di Santa Maria della Misericordia a cessare l'assistenza agli ammalati9, concentrando la propria attività verso l'assistenza degli esposti, tanto da sviluppare in pochi anni la più importanti struttura della bassa reggiana. Orfani, esposti e bambini indigenti erano inviati ai confratelli che inizialmente li alloggiavano all'interno dell'ospitale, per poi affidarli alle cure di famiglie locali di buon nome.
Il loro sostentamento era garantito dalla confraternita che semestralmente versava una quota alla famiglia ospitante, oltre a fornire il vestiario e quanto fosse necessario per l'educazione dell'esposto. Il priore compiva periodiche visite, così da accertarsi dello stato di salute e del livello di educazione del bambino dato in affido.
Anche le giovani ragazze in età da marito, ma prive di dote, trovavano assistenza e un concreto aiuto, così come i condannati a morte potevano contare sul conforto e sulla preghiera di suffragio degli "incappucciati" 10. Anche nella pratica religiosa la confraternita della Misericordia ebbe un ruolo centrale per la vita della città. Culmine dell'attività liturgica era la Settimana Santa ed in particolare la processione che la confraternita era solita organizzare il Giovedì Santo per le vie del borgo e la mattina della solennità del Corpus Domini, mentre nella Pasqua del 1564, per la prima
8 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46 II registro, Memoria sulle origini di Santa Maria. Al fine di ricomporre su base documentaria l'evoluzione della storia della confraternita e dell'ospedale in Santa Maria, risulta preziosa l'opera, rimasta manoscritta, cui è stato attribuito il titolo di "Memoria sulle origini di Santa Maria", di autore rimasto finora anonimo. Il testo, composto tra il 1765 e il 1770, si basa sulla trascrizione di notizie desunte da registri di carattere amministrativo o da atti notarili, risalenti al XV secolo, ed ancora posseduti nel Settecento dalla confraternita ed oggi andati perduti. È evidente, che pur con tutti i limiti che in sede di analisi storiografica una fonte indiretta comporta, il manoscritto rappresenti oggi la principale traccia per lo studio della confraternita.
9 ibidem. Nel manoscritto si fa anche cenno all'occupazione delle camere dell'ospitale, da parte delle truppe alemanne stanziate nel Principato in quegli anni. L'impossibilità di fornire un servizio decoroso, il dormitorio ormai spoglio e arredato con vecchi mobili, comportò l'abbandono della pratica infermieristica, da secoli svolta dalla confraternita.
10 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43. Nel documento è descritta con minuzie di particolari il rituale seguito in occasione del trasporto dal carcere al patibolo di un condannato a morte. La confraternita aveva cura sia dell'assistenza spirituale e materiale delle ultime ore del condannato sia di fornirgli degna sepoltura nell'ospitale e di far celebrare gli uffici di suffragio.
volta a Correggio, si tennero in Santa Maria le Sante Quarantore11.
Il culto alla Beata Vergine trovava ampio spazio nella vita del sodalizio: ogni domenica mattina si teneva la recita dell'ufficio della Madonna così il sabato al quale, dall'inizio dell'Avvento alla Pasqua, seguiva il canto delle litanie mariane. Piccole processioni erano organizzate in concomitanza con ogni festività mariana dell'anno, mentre era celebrata con particolare solennità la festa della Purificazione di Maria (2 febbraio), comunemente detta Candelora. Tale festa divenne col tempo la sagra del borgo, tanto da esser ancor oggi ricordata dagl'abitanti. Vi erano poi le celebrazioni legate ai lasciti o alla preghiera di suffragio per i defunti come la recita dell'ufficio nell'ottava dei morti.
Il Settecento vide la confraternita consolidare sempre più il proprio ruolo di istituzione assistenziale, ma i mutamenti politici e la presenza di truppe straniere nel Principato, da oltre cinquant'anni annesso ai domini estensi, furono alla base di un forte indebolimento del sodalizio. In soccorso dei confratelli arrivò nel 1709 l'ottenimento dalla Camera Ducale, del riconoscimento di ecclesiasticità, seguito nel 1726 dall'esclusione di tutte le proprietà dai libri di estimo12 che compensò le perdite dovute al calo delle rendite fondiarie e i forti esborsi per il mantenimento degli esposti e la quotidiana celebrazione delle messe di suffragio. Da una nota13 del sagrestano di Santa Maria datata 1725, si apprende che nella chiesa erano annualmente celebrate 2.928 messe, derivanti dalla sei cappellanie attive e da quelle officiate sull'altar maggiore.
La situazione si aggravò nel 1735, quando giunsero a Correggio truppe francesi che occuparono la chiesa trasformandola in un magazzino. Per oltre tre anni i confratelli furono costretti ad officiare in una cappella allestita, con non pochi problemi, al primo piano dell'ospedale nella camera delle Congregazioni14. Impossibilitati ad adempiere agli obblighi di suffragio, i confratelli si rivolsero al Vescovo di Reggio, monsignor Ludovico Forni, il quale li esentò dal rispetto dei legati, fino a cessata occupazione della chiesa. Ma le disavventure erano ben lungi dal passare. Nel 1750, fu eletto priore il nobile Antonio Cattania che fra notevoli difficoltà riuscì a portare a compimento i lavori di ristrutturazione di tutto il complesso confraternale, intrapresi nel 1738 all'indomani della riapertura al culto della chiesa15. Suo figlio Tommaso16 (Figura 1.4), divenuto priore nel 1770,
11 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46 II registro, Memoria sulle origini di Santa Maria. Nei successivi anni, questa pia pratica divenne appannaggio della confraternita del Corpo di Cristo, eretta ad inizio Cinquecento nella basilica collegiata di San Quirino, ma in virtù di aver dato inizio a tale devozione, la confraternita della Misericordia ottenne ugualmente, dai canonici di San Quirino, di ospitarla ogni tre anni in Santa Maria.
12 ibidem.
13 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43. Fino al 1735, in Santa Maria erano attive 7 "cappellania" che prevedevano la celebrazione di 340 messe annue ciascuna. Il numero delle messe celebrate è esorbitante, specialmente per una chiesa non parrocchiale; si tenga infine conto che la somma riportata dal sagrestano non calcolava le celebrazioni di precetto (domeniche e solennità) e dei numerosi servizi funebri effettuati dalla confraternita nell'arco dell'anno.
14 Meglio conosciuta come Sala della Congiura, l'appellativo deriverebbe da un avvenimento ivi accaduto il 29 marzo 1634, quando, a seguito dalla riunione segreta del Consiglio Generale del Principato, si deliberò l'allontanamento del principe Siro Da Correggio dallo Stato.
15 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46 II registro, Memoria sulle origini di Santa Maria.
arricchì la chiesa di nuovi arredi, ammodernando le camerate e le strutture di accoglienza degli esposti. In sostituzione dell'antico Gonfalone del sodalizio ormai logoro, fu acquistata, dall'ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio, una tela raffigurante la Beata Vergine della Misericordia, opera del pittore modenese Francesco Vellani (1687 - 1768)17. (Figura 1.3) Grazie alla conservazione di molti documenti settecenteschi, siamo in grado di ricostruire gli ultimi anni di attività dell'Ospitale anche nei minimi aspetti della vita quotidiana. Oltre al maneggio dei beni immobili e dei terrieri con le rispettive rendite, si sono salvate gran parte delle note di acquisto dei materiali edili impiegati nei lavori di ristrutturazione della chiesa, quelle delle per il mantenimento degli esposti o le spese per la sagrestia. Tra queste si sono salvati i mandati di pagamento per l'uva malvasia e per il vino da messa, direttamente acquistati dal sacerdote correggese don Antonio Nicolini che ne garantiva la conformità con le norme canoniche18. Ma i tempi erano ormai mutati: sulla spinta delle teorie illuministe molti stati europei avevano intrapreso una vasta serie di riforme dello stato sociale, dando vita alla pubblica assistenza ma a spese delle confraternite che nell'arco di pochi anni videro i loro beni incamerati nelle nuove istituzioni di carità e soppressi i loro oratori. Il 27 settembre 1782, per volontà del duca di Modena Ercole III d'Este, il conte Vincenzo Fabrizi, governatore di Correggio, soppresse la confraternita di Santa Maria della Misericordia, incamerandone i beni nella Congregazione di Carità19. Tutti gli arredi sacri furono messi all'asta e la chiesa, privata delle sue opere d'arte, chiusa al culto20. Anche l'oratorio di San Bartolomeo a Fazzano fu soppresso e, pochi mesi dopo, completamente demolito21. Per oltre un decennio la chiesa di Santa Maria fu ridotta a magazzino e gli annessi locali affittati come residenze private.
16 Tommaso Cattania, nacque a Correggio il 09 ottobre 1735 da Antonio e Ottavia Foresti. Nobile correggese, sposò nel 1765 la contessa Anna Maria Bettini di Carpi. Dal matrimonio nacquero Vincenzo e due femmine, Paola e Carlotta. Comandante delle truppe forensi di Correggio, come suo padre Antonio, fu Priore dal 1769 al 1772 della confraternita di Santa Maria della Misericordia. Rimasto fedele al suo sodalizio, anche a seguito della soppressione, operata nel 1782 da parte del Duca di Modena Ercole III d'Este, non cessò mai di svolgere l'attività di assistenza ai bisognosi, specialmente agli esposti. Nel 1796 la Comunità lo nominò Provvisore dei Conti, poi Vice Priore della stessa. Tommaso e la moglie Anna morirono nel 1803 a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro; per esplicita volontà del figlio Vincenzo, divenuto nel frattempo priore dell'Arciconfraternita del Ss.mo Sacramento, Tommaso fu sepolto all'interno del sepolcro dei confratelli del Sacramento, ancor oggi esistente all'interno dell'omonima cappella absidale della navatella sinistra della Basilica collegiata di San Quirino in Correggio.
17 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 44, busta 10. Sulla fine del Settecento la confraternita si trovò nella necessità di sostituire l'antico Gonfalone da tempo versante in pessimo stato, realizzato nel febbraio del 1600 dal ricamatore milanese Girolamo Pattucelli che, a sua volta, ne aveva sostituito uno più antico dipinto. A tale scopo il priore Tommaso Cattania, nel luglio del 1772, decise di acquistare per 7 Zecchini una tela raffigurante la Madonna della Misericordia e due confratelli oranti, di proprietà dell'Ospitale di S. Maria Nova detto degli Infermi, di Reggio Emilia. Il nuovo Gonfalone doveva avere notevoli dimensioni: sormontato da una grande croce dorata era sorretto da tre aste di legno, anch'esse dorate, dalle quali pendevano otto fiocchi di bavella gialla.
18 ibidem.
19 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 65, busta III, Congregazione generale dei luoghi Pii. Atti di protocollo (1781-1784). Notifica della soppressione della confraternita di Santa Maria della Misericordia e inventario dei beni; rogito datato 27 settembre 1782.
20.Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 65. 21 ibidem.
1.1.2 La rinascita ottocentesca: la Pia Unione dei Devoti di Santa Maria della Misericordia
Nell'ottobre del 1795, un gruppo di devoti alla Madonna della Misericordia, molti dei quali già membri della confraternita e capeggiati dal conte Vincenzo Gilocchi, cavaliere di Santo Stefano, ottennero dal Duca di Modena la riconsegna delle chiavi della chiesa ed il permesso di riaprirla al culto22. Per mettere a tacere le proteste dell'Opera Pia che da tredici anni era in possesso del fabbricato fu organizzata una sottoscrizione pubblica che raccolse influenti personalità della vita cittadina oltre a diversi sacerdoti, tra i quali il canonico Corrado Corradi, arciprete del Collegiata di San Quirino. Purtroppo la chiesa aveva subito pesanti danni dalle spogliazioni, ed in particolare la completa demolizione degli altari rendevano impossibile l'utilizzo. I lavori di restauro furono affidati all'architetto correggese Filippo Cattania (1753-1813), fratello dell'ex-priore Tommaso, ma l'improvvisa scomparsa del conte Gilocchi, rischiò di far naufragare il tutto23. Grazie alla generosità della famiglia Timolini e all'impegno di Francesco, nel frattempo nominato presidente unione di devoti, fu possibile completare i lavori di restauro. La Vigilia di Natale del 1796, l'arciprete Corrado Corradi, a nome del Vescovo di Reggio e fra le lacrime di gioia dei tanti correggesi accorsi ad assistere, benedì solennemente la chiesa riaperta24. Si cercò di recuperare, per quanto fosse possibile, gli antichi arredi della chiesa, un tempo adornata da sette altari, e di dotarla dei nuovi paramenti per le celebrazioni liturgiche25. Fu recuperato il Gonfalone ed altre tele di piccole dimensioni, acquistate all'epoca della spogliazione dalle stesse famiglie iscritte alla confraternita. Il 24 settembre 1797, con grande concorso di popolo, fu solennemente riportata nella chiesa la quattrocentesca statua della Madonna della Misericordia, per l'occasione riassemblata dagli apparatori Antonio Malaguzzi e Giuseppe Boselli26. (Figura 1.5) L'immagine era stata acquistata all'asta da Domenico Timolini, padre di Francesco, e donata a sua figlia, suor Giacinta clarissa di Santa Chiara, la quale di buon grado la restituì ai fedeli per riportarla nella sua chiesa. La semplice associazione di devoti si costituì in Pia Unione, dotandosi di uno statuto che prevedeva l'elezione di tre presidenti, ordinariamente in carica per un anno, ma riconfermabili più volte27. Furono anche nominati un sagrestano, un cancelliere, un cassiere e scelto un sacerdote quale cappellano della chiesa. La Pia Unione di Santa Maria della Misericordia, erede
22 Archivio Memorie Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 86.
23 Archivio Memorie Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 154, Memorie (1794 -1823) di Pietro Vellani, alle date suddette.
24 ibidem.
25 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46 II registro, Memoria sulle origini di Santa Maria.
26 Archivio Memorie Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 154, Memorie (1794 -1823) di Pietro Vellani, alle date suddette. Per approfondire si rimanda a: La Madonna di Santa Maria della Misericordia in Correggio, edito nel 2004 a cura della parrocchia dei santi Quirino e Michele Arcangelo.
spirituale della soppressa confraternita, ripristinò il tradizionale culto alla Vergine, con particolare attenzione alla festa della Purificazione di Maria (2 Febbraio), ma decaddero completamente la devozione a san Bartolomeo e a san Pietro, sostituite da quella per san Biagio. Cessarono anche gli antichi legati e la Pia Unione si limitò alla celebrazione di due Messe di suffragio per ogni sodale e benefattore defunto, oltre alla recita dell'ufficio funebre durante l'ottava dei morti. La scelta di costituire una Pia Unione anziché di ripristinare l'antica confraternita, evitò un'ennesima soppressione, all'indomani dell'editto della Repubblica Cisalpina (1798) che prevedeva l'incameramento dei beni e l'immediata chiusura di tutte le confraternite e degli istituti religiosi. Per tre lustri, dal 1799 al 1815, la Pia Unione fu retta dal nobile Giuseppe Rossi Foglia, il quale portò a compimento l'opera di ricostruzione del sodalizio iniziata dal Timolini28. Con la definitiva sconfitta di Napoleone e la Restaurazione, il sodalizio rientrò in possesso di alcuni antichi privilegi della confraternita, in particolare quelli di natura fiscale, che permisero agli amministratori di proseguire nella campagna di restauri. La Pia Unione di Santa Maria della Misericordia rimase attiva fino agli anni Quaranta del Novecento, proseguendo la sua opera di devozione alla Madonna, come previsto dallo statuto. L'avvento di nuove forme di aggregazione, nel panorama cattolico nazionale e locale, tolsero l'interesse dei fedeli verso una simile associazione, condannando la Pia Unione ad un lento esaurimento.
1.2 La chiesa e l'ospitale di Santa Maria della Misericordia in Correggio: storia e architettura
La complessità architettonica di Santa Maria della Misericordia e la completa mancanza di documenti antecedenti al XV secolo, ci impongono la massima accortezza nello sviluppare ipotesi sui primi secoli di vita dell'oratorio, il più antico dedicato alla Vergine presente in città29. La prima testimonianza documentaria, che ne attesta l'esistenza nel Borgovecchio, è contenuta nella la già menzionata visita Fogliani, del luglio 1439; dall'inventario emerge che la chiesa era dotata di tutte le suppellettili liturgiche necessarie per il culto fra cui un calice d'argento con piede di rame, una patena d'argento, due messali, due paliotti d'altare, due pianete e diversi candelieri. Sfortunatamente la cronaca non si sofferma a descrivere l'oratorio, né fornisce un elenco degli altari presenti nella chiesa, ma si limita a riportare la dedicazione della cappella maggiore alla Madonna
27 Archivio Memoria Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 86, Statuti delle Pia Unione di Santa Maria della Misericordia.
28 Cenni Storici sulla Pia Unione di Santa Maria della Misericordia di Correggio, Modena Tipografia Capelli, 1859, pp. 5-7.
29 Crf. Corrado Corradini, Per una storia .,cit., p. 124-25.
della Misericordia. Ma che forma aveva l'antico oratorio di Santa Maria? La risposta non è certo facile: probabilmente si trattava di un oratorio di dimensioni modeste, con un'unica navata e un solo altare. Se si studiano le tracce murarie, ancor oggi presenti in più parti della chiesa e dell'ospedale, è possibile immaginare che il primitivo oratorio avesse un diverso orientamento. Infatti, stando alle norme liturgiche in vigore fino agli inizi del Cinquecento, tutti gli edifici religiosi dovevano avere l'abside ad oriente, così da convergere la preghiera dei fedeli in direzione del "Signore che viene". Questa ipotesi porterebbe ad un rovesciamento delle parti della chiesa rispetto all'attuale conformazione, con l'antica abside posta in corrispondenza del portico e la facciata rivolta verso ovest, in asse con il secondo tratto di via Borgovecchio. Molto probabilmente si trattava di un oratorio di dimensioni modeste, con un'unica navata e un solo altare. Sul finire del Trecento, Correggio fu cinta di nuove fortificazioni che inglobarono il Borgovecchio all'interno del nucleo urbano. L'apertura di Porta di Santa Maria, posta a pochi metri dall'ospitale, sviluppò una nuova direttrice (nord-sud) che riorganizzò l'intero quartiere, spostandone il baricentro nel punto d'intersezione fra le due vie. (Figura 1.7) Similmente ad altri quartieri della città, dove piccoli slarghi delle contrade si trasformarono in "piazzette", così il Borgovecchio vide nascere la sua "piazza" sul lato settentrionale di Santa Maria. Questo nuovo assetto urbano determinò notevoli trasformazioni alla chiesa, ridefinendo i prospetti oltre all'apertura di un ingresso in corrispondenza della piazzetta. Una conferma è riscontrabile osservando l'ultima campata prima del presbiterio sul lato settentrionale, dove, a seguito del distacco dell'intonaco, sono riemerse le tracce di una porta murata e gli sguinci di una finestra tardo gotica. Altri segni sono rintracciabili nelle murature del sottotetto ed in quelle del setto che separa la chiesa dell'ospedale. Anche il cortile interno conserva parti dell'antico porticato a due ordini, probabilmente realizzato nella prima metà del Quattrocento. Nel 1465 su proposta del conte Manfredo da Correggio, confratello di Santa Maria della Misericordia, furono costruite, al piano superiore dell'ospitale, due nuove camere dotate ciascuna di quattro letti e di due armadi30. L'intervento non fu che un rimedio temporaneo, infatti, già nel 1490 tutto il complesso fu interessato da un nuovo cantiere che portò alla costruzione di una nuova chiesa, in grado di accogliere i numerosi fedeli che giornalmente vi si recavano per pregare. I lavori dovettero procedere molto celermente tanto da consentire al Vescovo di Reggio monsignor Bonfrancesco Arlotti, di consacrarla il 3 ottobre dell'anno successivo31. Visti i tempi ristretti, non si trattò della ricostruzione ex-novo di tutta la chiesa, ma piuttosto dell'ampliamento dell'antico edificio. Furono rafforzate tutte le murature perimetrali, rifatta la copertura e orientato l'edificio verso ponente, collocando la nuova facciata su via Santa Maria.
30 Archivio Memorie Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 86.
Per conferire maggiore stabilità alla chiesa, il lato settentrionale fu in più parti riedificato inserendo, nei punti dove il terreno era più cedevole, robusti archi di scarico. I lavori proseguirono fino al 1494, quando i confratelli acquistarono quattro colonne di marmo per sostenere il porticato della nuova facciata32, completato l'anno seguente insieme al selciato. Il portico, a tre fornici, era coperto da un semplice tetto in coppi spiovente verso la strada; la facciata, arretrata di alcuni metri rispetto l'allineamento del caseggiato, era a "capanna" sormontata da un timpano triangolare con guglie33. Nel 1501 fu costruita la una nuova sagrestia, ricavata dietro l'altare maggiore, mentre nel 1513 furono ultimati i volti della chiesa34. L'aula fu coperta da tre crociere a sesto ribassato, composte da una doppia camicia di muratura con costoloni interni che determinano, oltre ad un notevole spessore, un elevato peso tanto da rendere necessaria la costruzione di quattro robusti archi di contrasto. Molte importanti opere arricchirono negli anni la chiesa, fra le quali cinque opere di Antonio Allegri detto il Correggio (1489-1534). Di questo considerevole corpus di opere, certamente, il Trittico (Figura 1.9) rappresentava la più ragguardevole. Realizzato intorno al 1522-23 per l'altare maggiore della chiesa, allo scopo di costituire una ampia struttura, in grado di inglobare e riqualificare l'antica statua in terracotta della Madonna della Misericordia35, attribuita a Desiderio da Settignano (1430-1464), il Trittico si componeva di tre dipinti: una tela sommatale raffigurante un Cristo-Dio in gloria (Figura 1.10) e due laterali con le figure di San Giovanni Battista e San Bartolomeo apostolo. Rodolfo Papa nel suo recente saggio36 fornisce una preziosa e dirimente lettura iconologia sul rapporto che legava le tre tele alla scultura mariana, rinominando la deesis come il Trittico della Misericordia divina, rileggendo l'apparato iconografico come una manifestazione della pietà cristiana che scaturisce dal seno del Padre e attraverso la mediazione di Maria e dei santi patroni del sodalizio (Giovanni Battista e Bartolomeo apostolo), viene riversata sui fedeli. Per l'amico Melchiorre Fassi, confratello della Misericordia, l'Allegri dipinse una tela raffigurante i santi Pietro, Marta, Maria Maddalena e Leonardo, comunemente chiamata i Quattro Santi. Il quadro, inizialmente destinato alla chiesa di Santa Maria, fu oggetto di una lunga e controversa vicenda testamentaria che si risolse solamente nel 1538, con la nomina della confraternita quale unico erede
31 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46, II registro. Memoria sulle origini di Santa Maria.
32 ibidem.
33 Un idea abbastanza attendibile, benché approssimativa, del prospetto cinquecentesco ci è fornita dalla pianta della città di Correggio (1620 circa) conservata presso il Museo Civico. Nella raffigurazione la chiesa mostra il fronte leggermente arretrato rispetto l'attuale e sormontato da un timpano con pennacchi.
34 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46, II registro, Memoria sulle origini di Santa Maria.
35 Si veda a riguardo l'importante saggio di Valter Pratissoli, La Madonna della confraternita di Santa Maria della Misericordia in Correggio nelle testimonianze storiche locali, in La Madonna di Santa Maria della Misericordia in Correggio, edito nel 2004 a cura della parrocchia dei santi Quirino e Michele Arcangelo.
36 Si veda a riguardo l'importante saggio di Rodolfo Papa, Lettura iconologia del Trittico, in Il Correggio a Correggio, protagonisti e luoghi del Rinascimento, catalogo dell'omonima mostra tenutasi a Palazzo Principi dal 4 ottobre 2008 al 26 gennaio 2009, pp. 124-143.
e la tela sistemata nell'altare della famiglia Fassi37. Nel 1547 fu commissionata all'orafo Ettore Donati di Mantova la nuova croce d'argento per l'altare maggiore mentre, nel 1567, furono acquistate due nuove campane e rifatti i parati da messa38. Probabilmente sul finire del Cinquecento fu trasferito nel primo altare a sinistra dell'ingresso, l'affresco raffigurante la Madonna con il Bambino e i Santi Quirino e Francesco, anche detto Madonna dei limoni (Figura 1.11), realizzato dal giovane Correggio forse per l'antica Porta di Santa Maria, chiusa, nel 1557, a seguito del riordino del sistema difensivo cittadino39. Per far fronte alle crescenti richieste di assistenza, la confraternita acquistò nel 1573 la casa, prospiciente via Santa Maria, di proprietà del nobile Paolo Zuccardi e, due anni dopo, anche quella attigua di Vincenzo Brunorio. Lo sforzo economico apparve da subito elevato rispetto le esigue risorse del sodalizio e nel 1578, il conte Giberto XI da Correggio priore della confraternita, si fece promotore, congiuntamente ai due condomini dello stato ed ai rappresentanti delle più illustri famiglie della comunità cittadina, della realizzazione delle nuove strutture dell'ospedale. In soli due anni fu portato a compimento l'ammodernamento di tutto lo stabile, aumentando il numero delle camere e dei posti letto a disposizione degli esposti e degli ammalati40. Otto anni prima la contessa Claudia Rangone, moglie di Giberto, aveva donato all'altare della Madonna della Misericordia preziosi ornamenti in cuoio lavorato, contribuendo ad incrementare la dotazione di suppellettili liturgiche della sagrestia. Nell'inventario dei beni redatto nell'ottobre del 1598 si legge che la
37 David Ekserdjian, Correggio, Silvana Editoriale 1997, pp. 54-56; Elio Monducci, Il Correggio, la vita e le opere nelle fonti documentarie, Silvana Editoriale 2004, pp 54-67; Maddalena Spagnolo, in Correggio e l'antico, catalogo dell'omonima mostra, Roma 2008, p. 92, n. 4.
38 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46, II registro, Memoria sulle origini di Santa Maria.
39 Benché esista una consolidata tradizione che vuole il dipinto provenire dall'antica chiesa di San Quirino in castello, l'assoluta assenza di documenti o di riferimenti coevi sicuri, oltre alla scelta dei santi raffigurati (titolari delle due principali chiese della Correggio del primo Cinquecento), favoriscono la formulazione di una nuova ipotesi d'origine: la provenienza dell'affresco dalla vicina porta di Santa Maria, chiusa nel 1557 a seguito del riordino del sistema difensivo cittadino30. A favore di questa teoria vi è l'iconografia stessa della scena: la dedicatio urbis della città di Correggio, rappresentata nel modello offerto dal patrono san Quirino, vescovo e martire, affiancato da san Francesco d'Assisi, alla protezione della Vergine e del Bambino, ritratta seduta con il divin Figlio in grembo secondo il modello che potrebbe esser stato ispirato della statua della Madonna della Misericordia.
40 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43, Convenzione per la fabbrica dell'ospedale e chiesa, nota di spese. L'interesse di questo documento, già citato da Corradini nel suo studio sulla Confraternita di Santa Maria, non è soltanto di carattere "paleografico", in quanto raccoglie molte sottoscrizioni autografe di importanti personalità correggesi, quanto piuttosto di carattere propriamente storico. Il documento, oltre all'elenco degli obblighi dei sottoscrittori, riporta con minuzia il costo, la quantità e la provenienza dei materiali impiegati per la costruzione delle nuove camere dell'Ospitale di Santa Maria. Inoltre, attraverso l'individuazione dei firmatari e della loro posizione sociale, si desume un quadro abbastanza completo delle relazioni tra la confraternita e i membri delle famiglie correggesi e della loro partecipazione alla vita dello stesso sodalizio. Ad una prima lettura delle sottoscrizioni si segnalano i nomi di Simone Zaccarelli, già arciprete di San Faustino di Rubiera e vicario generale della diocesi di Taranto per conto del cardinale Girolamo Da Correggio; di Flaminio Brunorio, futuro segretario del Principe Siro e vicario foraneo in quegli anni; di Giulio Leprotti rettore della chiesa sub urbana di San Giovanni Battista; di Francesco Astolfi, eletto fra gli Anziani della città; del notaio Ottavio Schiattarini priore della Confraternita di Santa Maria della Misericordia. Occorrerebbe svolgere un'analisi particolareggiata su questo documento, i cui risultati dovrebbero rivelarsi estremamente interessanti a proposito della "religione cittadina".
chiesa era in possesso di molte suppellettili tra le quali, quadri cioè pitture di Nostro Signore della Madonna in tutto compresa una di rilievo n°541. Il riferimento al Trittico e alla statua della Madonna della Misericordia è palese, mentre più incerto è quello alla tela dei Quattro Santi e all'affresco trasportato della Madonna presso la porta anche detta dei limoni42. La costante necessità di reperire fondi per sostenere le ingenti spese di gestione dell'ospitale, spinse i confratelli ad assecondare i desideri del principe Giovanni Siro da Correggio d'Austria (1590-1645), cedendogli le tele componenti il Trittico del Correggio43. Nel marzo del 1613 le tre tele furono rimosse dall'ancona e consegnate al principe; al loro posto furono eseguite delle copie di inferiore qualità che, oltre a privare la chiesa di un eccezionale tesoro, alterò l'armonico rapporto istauratosi fra i quadri e la statua della Madonna. Gli originali presero la volta di Mantova dove furono dispersi in collezioni private. Nel 2008 nell'ambito della mostra correggese dedicata all'Allegri è stata riconosciuta dal comitato curatore l'autografia della tela raffigurante il Creatore sull'iride tra angeli, già cimasa del Trittico, ed oggi conservata nella Pinacoteca Vaticana. Coi fondi raccolti dalle alienazioni e dal pagamento anticipato dei legati, nel 1619 la confraternita decise di rifare il presbiterio e di sistemare il pavimento della chiesa che in più
41 Il documento, conservato presso l'Archivio Storico Diocesano, riporta che il Vicario Generale diede l'ordine al priore di rimuovere e vendere gli altari portatili incassati nella mensa,così da fronteggiare le ingenti spese della confraternita.
42 Probabilmente sul finire del Cinquecento fu trasferito nel primo altare a sinistra, l'affresco raffigurante la Madonna con il Bambino e i Santi Quirino e Francesco, anche citato nei documenti con il nome di Madonna della porta, realizzato dal giovane Correggio forse per l'antica porta di Santa Maria, chiusa, nel 1557, a seguito del riordino del sistema difensivo cittadino. Per via della presenza alle spalle dei personaggi di una folta siepe, carica di grossi agrumi, la tradizione locale lo ricorderà anche con il titolo di Madonna dei limoni, nome ancor oggi utilizzato dagli studiosi per identificare l'opera.
43 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43. Lettera del Vescovo monsignor Claudio Rangone agli ufficiali della confraternita nella quale l'ordinario diocesano ordina, pena l'incorrere nelle sanzioni canoniche di esibire il permesso avuto da Roma di poter togliere dall'altar maggiore della loro chiesa il Trittico (1613). Archivio Memorie Patrie, Biblioteca Comunale di Correggio, cartella 113, Antonio Allegri, Documenti bibliografici e notizie storiche, su foglio sciolto con grafia di Michele Antonioli è ricopiato un estratto del libro mastro della Confraternita di Santa Maria della Misericordia, oggi perduto, dove il massaro riporta nel dettaglio la vendita dei tre quadri al principe Siro ricordando di ave ricevuto le debite autorizzazioni del Vescovo di Reggio e di Roma e di aver sostituiti gli originali con copie. Sul medesimo foglio, con medesima grafia ma in un successivo momento sono riportate le misure in braccia correggesi delle tre tele. Ovviamente si trattano delle misure delle copie che trovarono posto nell'ancona, negli spazi lasciati liberi dagli originali. Ipotizzando che il braccio utilizzato fosse quello agrario pari a 53 cm. e che ogni braccio era diviso in 12 once pari a circa 4,42 cm., le dimensioni dei quadri risulterebbero: Umanità di Cristo o Ascensione, alta braccia 2, larga braccia 1 e once10 (106 x 97 cm. circa); San Giovanni Battista e San Bartolomeo Apostolo alta braccia 2 e once 10, larga braccia 1 (152 x 53 cm. circa). Di conseguenza è ipotizzabile che la nicchia centrale contenente la Madonna della Misericordia fosse alta quanto un laterale e larga circa come il quadro superiore (152 x 96 cm.). La trattativa ebbe inizio nel dicembre del 1612 con il sopralluogo in Santa Maria del pittore Jacopo Borbone di Novellara, inviato da don Siro d'Austria all'epoca conte di Correggio a epertizzare le tele. Il 6 marzo del 1613 durante la vistia pastorale di monsignor Claudio Rangone, vescovo di Reggio, dopo aver rilevata l'abusisva sostituzione degli originali diede ordine affinché tutto come in precedenza. Iniziò un duro contenzioso fra il vescovo e i confratelli della Misericordia determinati a cedere le tele a Siro. L'opposizione di monsignor Rangone fu rimossa solamente ain seguito all'intervento diretto della Camera Apostolica ed in particolare del cardinale Scipione Borghese, all'epoca prefetto del Tribunale della Segnatura. Il 20 novembre 1613 con lettera indirizzata al dottore Ettore Donati, priore di Santa Maria della Misericordia, il vescovo di Reggio forniva il proprio assenso alla vendita, avvenuta tre giorni dopo alla presenza del notaio Paolo Camillini di Correggio e degli Ufficiali della confraternita di Santa Maria, Siro acquistò le tre tele al prezzo di 300 ducatoni d'oro da lire 8, versati alla confraternita in tre rate annuali all'interesse dell'8% annuo. Al posto
punti era sfondato. Nonostante la perdita di tre opere del Correggio, Santa Maria fu arricchita da nuovi altari, frutto di importanti lasciti di devoti e dell'istituzione di ben sei cappellanie di suffragio. Dalle indicazioni contenute nella seicentesca Nota delli altari et sacrestia 44 e nell'inventario dei beni redatto nel 1704 in occasione della visita Picenardi45 alla chiesa, è possibile ricostruire l'antica disposizione degli altari di Santa Maria. Partendo dal fondo della chiesa sulla parete di sinistra, il primo altare che si incontrava era quello della Madonna presso la porta, seguito da quello del Crocefisso (in seguito dedicato a Sant'Anna) 46, e dal celebre altare di Santa Marta, di proprietà della famiglia Fassi47. Sulla parte opposta il primo altare, verso il presbiterio, era quello di San Carlo Borromeo (già di San Pietro Martire) 48, seguito da quello di San Giovanni Battista49 e
degli originali furono definitivamente poste le copie di inferiore qualità, realizzate mesi prima probabilmente dallo stesso Borbone, alterando l'armonico rapporto studiato dal Correggio fra i quadri e la statua della Madonna.
44 Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, chiese e parrocchie, filza 91. "Correggio" (confraternite, ospedali, ecc..). La Nota delli altari et sacrestia et oblighi della chiesa di Santa Maria riporta fedelmente la dedicazione degli altari della chiesa. Il testo è stato in parte riprodotto in M. Pirondini - E. Monducci, La pittura del Cinquecento a Reggio Emilia, Milano 1985, p. 250. Si tratta quasi certamente di una descrizione fatta in preparazione di una visita pastorale non identificabile con sicurezza, presumibilmente databile intorno al 1621-22 (Crf. Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia Sacre visite Pastorali. Filza 3-4, Liber primis visitatiorum del cardinale Alessandro d'Este, 1622-1623; visita a santa Maria: 31 ottobre 1622, cui segue la visita di Paolo Coccapani, 1625-1635; visita a Santa Maria: 21 novembre 1628) . Questo documento, che Elio Monducci ha datato tra Cinque e Seicento, è stato ritenuto probante della presenza sull'altare maggiore dei dipinti costituenti il Trittico della Misericordia del Correggio, ma come dimostrato da Valter Pratissoli si riferisce in realtà alle copie che sostituirono gli originali, acquistati nel 1613 da don Siro d'Austria da Correggio (Crf. V. Pratissoli, La Madonna della confraternita di Santa Maria della Misericordia in Correggio nelle testimonianze storiche locali, in La Madonna di Santa Maria della Misericordia in Correggio, Correggio 2004, p. 77). Stando a quanto scrive Pratissoli, l'elemento che postdaterebbe la Nota è costituito dalla denominazione del quarto altare a san Pietro Martire con la seguente precisazione: et questo altare hora si ritrova sfornito perche la Compagnia la datto ad un particolare che fa fare il quadro a Bologna. La nuova assegnazione comportò una diversa intitolazione dell'altare a san Carlo Borromeo, conservando tuttavia la memoria iconografica della precedente, Nuovo patrono dell'altare divenne il mercante Orazio Capretti (Archivio Storico Notarile di Correggio, busta 655. notaio F. Torricelli, filza IV, rogito del 6 luglio 1630; testamento di Orazio Capretti: il testatore chiedeva di essere sepolto presso l'altare di San Carlo in santa Maria da lui stesso eretto). Inoltre alla fine della Nota, si specificava che, per soddisfare gli obblighi delle messe, officiavano sette cappellani: questi erano ancora sei nel 1618, ma già sette nel 1625 (Crf. Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia Sacre visite Pastorali. Claudio Rangone. Filza 5: Visitationes annis 1618; c[33] verso. Cfr. inoltre Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43: Spesa fatta l'anno 1625 dal sindaco: lire 1708 «in sette cappellani»). Alla luce di questi e dei precedenti riferimenti la Nota delli altari assegnata dal Monducci al Cinque Seicento e dal Ciroldi al 1655 ca. o al 1652 (I dipinti di Antonio Allegri nella chiesa di Santa Maria della Misericordia di Correggio, in La Ricerca storica locale a Correggio. Bilanci e prospettive. Correggio 2004.), deve essere datata sicuramente dopo il 1614 e prima del 1630.
45 Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Sacre visite pastorali. Visita Picenardi 1702-1704; Filza 16, fasc. "Correggio": De oratorio S. Marie Misericordie Corrigli, die 25 augusti 1704.
46 ibidem. Nella descrizione allegata alla visita pastorale si ricorda che nel quinto altare, dedicato a Sant'Anna venivano celebrate alcune messe a carico degli eredi di Giovani Affarosi. Questi fece testamento nei giorni 21 e 22 e morì il 23 agosto 1614 (cfr. Archivio Storico Notarile di Correggio, busta 202, notaio P. Capellini, filza IX, rogiti nn. 124 e 125; Archivio parrocchiale di San Quirino, Libro dei morti, 1592-1630). Tutta l'eredità Affarosi confluì in Gabriele, morto nel 1630 (cfr. Archivio Storico Notarile, busta 655 notaio F. Torricelli, filza IV, rogito 6 novembre 1630:divisione dei beni di Gabriele Affarosi tra privati e confraternite di Santa mAria e Santissima Trinità).
47 Il medesimo altare, dalla fine del XVII secolo, è indicato col titolo "di San Pietro". Probabilmente la nuova denominazione fu determinata da una maggiore devozione al Principe degli apostoli (raffigurato nella pala assieme ai santi Marta, Leonardo e Maria Maddalena) che però non cancellò il culto a santa Marta, in onore della quale si continuò a celebrare il 29 luglio una solenne messa in canto.
48 Dalla citata cronaca della vista Picenardi, del 1704, l'altare di San Carlo risulta ancora patronato di un Capretti, Alessandro. Quanto alla pala, che però non è descritta accuratamente, viene avanzato il nome del probabile autore: Icona est celeberrimi Gipsi. L'assegnazione a Francesco Gessi (Bologna 1588 - 1649) verrà poi raccolta dall'Oretti; tuttavia l'opera risulta oggi tra quelle ricordate dalle fonti ma irreperibili o perdute: Correggio. Chiesa della
dall'altare delle Sante Lucia ed Agata50. Altrettanto generose furono le donazioni per l'altare maggiore tanto che, nel 1652 i confratelli fecero indorare l'ancona al cremonese Andrea Spada e nel 1669, il confratello Francesco Righetti donò alla Madonna della Misericordia, una lampada d'argento recante la sua arma51. Nel 1689 furono eseguiti dal correggese Marco Bianchi (1636-?), nel sottoportico esterno ai lati della porta d'ingresso, due pitture raffiguranti l'Annunciazione e la Natività, oggi completamente scomparse52. Due anni dopo, il capomastro Clemente Merli, fu chiamato ad eseguire diverse opere di manutenzione sulla chiesa e sull'ospedale. Furono sostituiti i "piatti" in pietra alla base delle colonne del portico, imbiancata la facciata, rimesse le cornici all'altare maggiore, rifatto il pavimento del presbiterio e riparati i gradini della cappella del Crocifisso, rifatto il tinteggio della sagrestia, sostituiti i coppi rotti del campanile e della chiesa. Altri lavori furono eseguiti nelle cucine dell'ospitale, nelle camere da letto e nel cortile, oltre al ricoprimento della fogna53. Il crescente numero di bambini "esposti", costrinse la confraternita ad acquistare nel 1699 un'altra casa, di proprietà del nobile Paolo Francesco Grillenzoni, posta dietro la sagrestia lungo via Borgovecchio54, estendendo l'intero complesso dell'ospitale a buona parte dell'isolato intorno alla chiesa, senza contare le singole abitazioni poste nel quartiere e utilizzate come case di prima accoglienza per i bambini e per gli indigenti. Negli stessi anni, sul modello della chiesa di San Sebastiano, fu costruita la nuova facciata di Santa Maria, sostituendo l'antico portico a colonne di pietra con una più solida struttura in muratura, composta da pilastri quadrangolari e volte a crociera a sostegno di un'ampia cantoria. Dell'antica
confraternita di Santa Maria. San Carlo Borromeo e San Pietro Martire (Oretti, Ms, 128 c 77); cfr E. Negro, Francesco Gessi, in La scuola di Guido Reni (a cura di M. Pirondini - E. Negro), Modena 1992, p. 249. Dalla visita Forni apprendiamo che oltre ai santi Carlo Borromeo e Pietro martire vi era raffigurata anche la Madonna (cfr. Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Sacre visite pastorali, Forni Ludovico, 1724-1729. Filza 22) .
49 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46, II registro. La tradizione attribuiva questa pala al figlio del Correggio, Pomponio Allegri.
50 Francesco Cafarri, Dieci secoli di storia dei Luoghi Pii di Correggio dall'anno 950 al 1920, dattiloscritto presso la Biblioteca Comunale di Correggio, senza collocazione. Dallo stesso testo è stata ricavata una Breve memoria sugli ospedali di Correggio (1173 - 1922), dattiloscritto conservato presso la Biblioteca Comunale di Correggio con collocazione «20.4.32». Secondo quanto scrive Cafarri, il quadro raffigurante le sante Lucia e Agata e la Beata Vergine Maria, fu dipinto nel 1652 da un figlio del nobile Alberto Guzzoni. Nella visita pastorale del vescovo Ludovico Forni, al quadro risulta aggiunta la figura di San Biagio vescovo e martire.
51 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46, II registro. Francesco Righetti fu priore della confraternita di Santa Maria della Misericordia dal 1632 al 1640 circa. Durante il suo mandato la confraternita portò a termine i lavori di restauro dell'ospitale di San Bartolomeo a Fazzano, intrapresi dal suo predecessore, il nobile Ubertino Zuccardi.
52 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46, II registro. Le scarse e non sempre attendibili informazioni, ad oggi in nostro possesso, sulla vita e sulle opere di Marco Bianchi ci sono fornite dalle Biografie di illustri correggesi scritte da Ernesto Setti e dall'opera di Quirino Bigi intitolata Notizie di Antonio Allegri, di Antonio Bartolotti suo maestro e di altri Pittori ed artisti correggesi. Vedi anche Gianluca Nicolini, La "confessio" della città di Correggio davanti ai santi Patroni, in Correggio Produce 2006, pp. 100-101.
53 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43.
facciata si salvarono solo il portale e le murature del sottoportico con i dipinti del Bianchi, mentre della parete superiore, dovendo far posto al grande archivolto della cantoria, non rimase nulla. Pur non conoscendo il nome del progettista, è facile intuire il desiderio di mimetizzare il nuovo prospetto con il resto dell'ospedale, scegliendo per il tempio sacro il medesimo rapporto volumetrico già in essere negli edifici attigui ed impiegando nella decorazione l'ordine tuscanico, semplice e lineare. Osservando la facciata si ha conferma immediata della linearità quasi manierista dell'architettura; il fronte è coronato da un massiccio cornicione in facciavista sagramata, sorretto da quattro paraste poggianti su di un secondo cornicione posto a divisione dei due volumi del prospetto. Quattro paraste, anch'esse sagramate e addossate ai pilastri del portico, sostengono la trabeazione tuscanica decorata con triglifi alternati a rettangoli vuoti e, al tempo stesso, dettano il ritmo a tutta la facciata. Tra le arcate del portico, trovano ancor oggi posto cinque paracarri di marmo, acquistati nel dicembre del 1750 dal priore Antonio Cattania per abbellire il fronte su via Santa Maria ed impedire il libero accesso al porticato55. Con l'arrivo in città, nella primavera del 1735, di un contingente di truppe francesi alleate dell'esercito estense, la chiesa fu adibita a magazzino, costringendo i confratelli ad allestire una cappella provvisoria nella camera delle Congregazioni. Certo che l'occupazione della chiesa non sarebbe durata a lungo, nell'agosto dello stesso anno, il priore Vincenzo Gianotti commissionò a sue spese, al modenese Gian Domenico Traeri, la costruzione di un nuovo organo da porre nella cantoria della chiesa56. Ad ottobre, col perdurare dell'acquartieramento dei soldati in Santa Maria, il priore decise di far costruire, nella Camera delle Congregazioni, un altare in muratura. Del disegno fu incaricato l'architetto correggese Giorgio Magnanimi (1682-1775), allievo del Bibbiena, mentre per la realizzazione ci si avvalse del mastro scagliolista Pietro Bardi57. (Figura 1.13)
54 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 44. Dal rogito apprendiamo che la casa, ancor oggi esistente, era posta in Correggio annessa a detto Hospitale a cui confina da una il medesimo Hospitale, dall'altra la via pubblica, dall'altra detto sig. Grillenzoni, e dall'altra il sig. canceliere Nicolò Carisi.
55 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43.
56 ibidem. Nel contratto si stabiliva che l'organo dovesse essere simile (per dimensioni e foggia) a quello della chiesa delle Monache di Santa Chiara, realizzato, nel 1719, dallo stesso Traeri per la soppressa confraternita della Trinità. In seguito della soppressione della confraternita di Santa Maria (1782) l'organo fu posto all'asta; acquistato dai Padri Domenicani fu trasferito nella chiesa di Madonna della Rosa. Stando alla testimonianza diretta del cav. Medoro Ligabue, organista da oltre sessant'anni della Basilica Collegiata di San Quirino in Correggio, l'organo Traeri, benché smontato e non più funzionante, rimase in Madonna della Rosa fino agli anni Quaranta del Novecento, per poi sparire nel dopoguerra. Ad oggi non sappiamo dove sia stato trasferito o da chi sia stato acquistato. Per quanto riguarda l'organo della soppressa confraternita della SS.ma Trinità, nel 1720, passò assieme alla chiesa alle Monache di Santa Chiara. Da queste fu venduto, sul finire del Settecento, alla parrocchiale di Mandriolo, dove ancor oggi lo si può ammirare nella cantoria in controfacciata. Maggiori notizie su questo strumento sono raccolte nel puntuale studio condotto da Sauro Rodolfi e Andrea Plichero, intitolato L'organo Domenico Traeri (1719) e le campane della chiesa di Mandriolo, edito a cura dalla stessa parrocchia nel dicembre del 2000.
57 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43.
L'occupazione della chiesa cessò solamente nel febbraio del 1738, lasciando pesanti danni agli altari e al pavimento della chiesa58. Dal 1756 al 1758, tutto il complesso dell'ospitale fu interessato da un nuovo grande intervento di restauro, finalizzato a ridonare funzionalità e "prestigio" alle vecchie strutture. Purtroppo i documenti non ci hanno tramandato il nome del progettista che fu incaricato di seguire i lavori, ma è probabile che i confratelli si rivolsero, ancora una volta, alla valida opera del Magnanini. Nello specifico i lavori coinvolsero il cortile, lo scalone e tutti gli ambienti del primo piano dell'ospitale, compresa la camera delle Congregazioni che fu alzata e coperta con una nuova volta a padiglione in muratura, così da adattarla alla volumetria della cantoria59. Nell'estate del 1761 fu intrapreso il restauro della sagrestia e del presbiterio, seguito dal tinteggio e dalla decorazione dei nuovi ambienti e rifatto gran parte del selciato in cotto della chiesa60. La decorazione dei nuovi ambienti fu affidata a Francesco Cipriano Forti (1713-1779) che dal 1768 al 1772, a più riprese, dipinse a chiaroscuro tutta la Camera delle Congregazioni e diversi mobili dell'ospitale61. Nel luglio del 1771 fu intonacata la facciata della chiesa e risistemata quella dell'ospitale. I lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato sono documentati fino a pochi mesi prima della soppressione della confraternita, così come ci è pervenuto un puntuale elenco dell'asta con la quale furono alienate tutte le suppellettili della chiesa, compresa la tela dei Quattro Santi del Correggio62. Avendo perduto con la sciagurata "vendita di Dresda" tutte le opere dell'Allegri presenti nella Galleria Ducale, nel 1786, Ercole III d'Este decise di fare asportare dal suo altare l'affresco della Madonna dei limoni e di trasferirlo a Modena. In soli due anni la città vide scomparire le ultime due opere del Correggio superstiti. Per oltre un decennio la chiesa di Santa Maria fu ridotta a magazzino e solo nell'ottobre del 1795, grazie all'intervento di un gruppo di devoti fu possibile riaprire al culto l'edificio, benché avesse subito pesanti danni dalle spogliazioni e la completa demolizione degli antichi altari63. L'unione di devoti incaricò l'architetto Filippo Cattania (1753-1813), di dirigere il restauro e già nel mese di novembre iniziarono i lavori. Fu dapprima rifatto il selciato della chiesa, sostituendo il vecchio pavimento in cotto con un battuto alla
58 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43. All'indomani della riapertura della chiesa furono approntanti diversi lavori di restauro che interessarono oltre al selciato interno e del sottoportico, il rifacimento di molti altari della chiesa e il restauro dell'ancona dorata della cappella maggiore.
59 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46, II registro, Memoria sulle origini di Santa Maria.
60 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 44.
61 ibidem.
62 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 65, busta III, Congregazione generale dei luoghi Pii. Atti di protocollo (1781-1784). Notifica della soppressione della confraternita di Santa Maria della Misericordia e inventario dei beni; rogito datato 27 settembre 1782.
63 Archivio Memorie Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 86.
veneziana64, poi si diede inizi la costruzione del nuovo altare maggiore, portata a termine entro il marzo del 1796. (Figura 1.14) Il mese successivo fu montata la nuova balaustra in ferro del presbiterio e iniziati i lavori per costruire l'altare laterale destro, dedicato alle Anime del Purgatorio65. Ad agosto fu terminato il pavimento del sottoportico e il nuovo altare del Crocifisso, posto nel mezzo della parete sinistra, dove sorgeva l'antico66. Dell'antico apparato liturgico di Santa Maria furono recuperate poche cose, tra queste alcune tele di modeste dimensioni e il grande Gonfalone processionale acquistato, all'indomani della soppressione della confraternita, da una famiglia legata al sodalizio. Non potendo recuperare l'originario organo Traeri, nel giugno del 1797, Francesco Timolini presidente della Pia Unione, decise di acquistare dal parroco di Bagnolo in Piano un antico organo positivo e di collocarlo sulla cantoria della chiesa67. Decaduto l'utilizzo della Gonfalone come stendardo, i responsabili della Pia Unione decisero di riadattarlo come "velario" della statua. Fu costruita, dietro l'ancona dell'altare, una macchina scenica che consentisse all'occorrenza di calare a scomparsa il quadro, scoprendo, in concomitanza con particolari festività liturgiche, la sottostante nicchia con il simulacro della Madonna. Per oltre un ventennio la chiesa non subì rilevanti modifiche e solo nel 1833, fu innalzata la nuova torre campanaria, coperta da una cupola in rame dal modenese Reggiani68. Nel 1837 fu nuovamente riparato il pavimento della chiesa e su perizia dell'architetto Francesco Forti (1801-1864), fu affidata per cottimo la ricostruzione degli ampi tetti del caseggiato al mastro
64 Archivio Memorie Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 154, Memorie (1794 -1823) di Pietro Vellani, alle date suddette. L'impresa esecutrice dei lavori di pavimentazione della chiesa era di proprietà del mastro muratore Luigi Scaltriti, esperto realizzatore di battuti veneziani. La stessa impresa aveva realizzato alcuni anni prima il nuovo pavimento della chiesa di San Francesco e sempre alle dipendenze di Cattania, nel 1788, quello del nuovo Palazzo Comunale.
65 Archivio Memoria Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 86. In una nota delle spese fatte per la costruzione dei tre nuovi altari, stilata dal presidente della Pia Unione, Francesco Timolini, leggiamo che gli altari furono tutti disegnati da Filippo Cattania e realizzati per la parte muraria dal muratore Pietro Riccò, mentre il decoro a stucco fu opera del correggese Antonio Guidetti detto Picchiotti. La nota è preziosa non solo perché conferma che tutte le maestranze impiegate nei lavori di restauro fossero di provenienza locale, quanto più perché fornisce un elenco puntuale di tutti i materiali occorsi, della quantità impiegata e della provenienza, fondamentali per sviluppare le ipotesi di restauro del complesso architettonico.
66 ibidem. Dalle "Memorie" di Pietro Vellani apprendiamo che la costruzione del nuovo altare del Crocifisso fu iniziato il 21 dicembre del 1795 ad opera del muratore Pietro Riccò ma a causa di una sua malattia i lavori alla chiesa si protrassero per molti mesi.
67 Archivio Memoria Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 154, Memorie (1794 -1823) di Pietro Vellani, alle date suddette e Archivio Memoria Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 86. Si tratta di un magnifico organo positivo degli inizi del Seicento, con facciata lignea intagliata a cinque campate. Francesco Timoli, presidente della Pia Unione, lo acquistò da don Pietro Lusuardi, parroco di Bagnolo per la cifra di £ 1033.15 corrispondenti a circa 23 zecchini reggiani. Pietro Vellani, nella sua Cronaca, riporta che fu chiamato ad accordarlo Quirino Asioli, organaro e orologiaio correggese, il quale lo reputò un eccellente strumento. L'organo è oggi conservato nella Basilica di San Quirino.
68 Cenni storici intorno alla Chiesa e Pia unione di S. Maria della Misericordia, Modena tip. Antonio Angelo Cappelli. Opuscolo a stampa edito dalla Pia Unione di Santa Maria della Misericordia nel 1859, a conclusione dei lavori di ristrutturazione del complesso. A pagina 8 è riportato il nome del mastro artigiano autore della cupola in rame del nuovo campanile.
muratore Angelo Diacci69. In occasione della proclamazione di Papa Pio IX del dogma dell'Immacolata Concezione (1854), tutto l'apparato decorativo interno ed esterno della chiesa fu rinnovato dal pittore Andrea Capretti (1821-1870c.), su progetto dall'architetto Forti, al quale fu affidato il ridisegno della facciata settentrionale della chiesa70. L'intervento di Forti comportò la trasformazione del fianco di Santa Maria in forme neogotiche eclettiche: furono rivestite con finte bifore le finestre settecentesche della navata, applicati finti contrafforti e realizzata, come fascia marcapiano del sottotetto, una "frappa" ad archetti gotici. Il carattere goticheggiante del prospetto fu accentuato dalla decorazione geometrica a chiaroscuro realizzata dal Capretti, purtroppo oggi completamente perduta. All'interno, Capretti decise di seguire lo stile neoclassico piranesiano già impiegato da Filippo Cattania nel comporre gli altari, Cinquant'anni prima; con grande maestria reinterpretò le volute e i festoni delle ancone, realizzando la decorazione a chiaroscuro delle cinquecentesche volte a crociera giocando con toni grigio, verdi e rosacei. Le pareti furono incorniciate da fasce geometriche a chiaroscuro, impreziosite, nelle parti libere, da finte nicchie ospitanti le immagini dei santi titolari degli antichi altari della chiesa. Di maggior gusto eclettico risulta la decorazione del presbiterio dove le pareti sono decorate a finto damasco blu su fondo ocra, mentre la volta tetrapartita riporta allegorie mariane,derivanti dalle litanie lauretane. L'archivolto del presbiterio è adornato da due grandi festoni classicheggianti, con foglie d'acanto e di palma intrecciate fra di esse, sormontato al centro da un cartiglio in chiaroscuro, recante un motto mariano. Similmente furono decorati tutti gl'archivolti della chiesa, creando un elegante ritmo di ascesi verso l'altare maggiore. La forte umidità di risalita e i danni provocati dai terremoti del 1996 e del 2000, hanno in più parti rovinato l'opera del Capretti, senza però cancellarne il carattere fantasioso e fortemente romantico, prerogative dell'arte decorativa dell'epoca. Sul finire degli anni Settanta del secolo scorso furono eseguiti un serie di interventi di restauro non filologici71 che alterarono la staticità dell'edificio aumentando il degrado della chiesa, diventato drammatico dopo i citati sismi che hanno provocato il lesionamento di molte parti strutturali e causato il parziale crollo della volta della camera della Congiura.
4.1 Soglie storiche costruttive
69 ibidem.
70 ibidem. Nella memoria, densa di particolari di colore e di cronaca, si riporta anche il nome del mastro muratore che venne chiamato ad eseguire il progetto di Forti, tale Geminiano Marchi, attivo in quegli anni in Correggio con una piccola impresa edile.
71 Autore dell'intervento di restauro, che ottenne l'autorizzazione dell'allora Soprintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, architetto Germana Aprato, fu l'ingegnere Riccardo Bigi di Reggio nell'Emilia.
Inquadramento storico
I numerosi interventi di ampliamento o rifacimento del complesso, succedutisi nel corso dei secoli, hanno richiesto l'elaborazione di un attento studio archivistico che ha consentito di ricostruire la storia del fabbricato, raccolta all'interno della relazione storica.
Di seguito si riporta l'elenco, per soglie storiche, delle principali modifiche subite dal complesso architettonico di Santa Maria della Misericordia:
1. luglio 1439: dalla relazione allegata alla visita pastorale Fogliani emerge che la confraternita dispone di una chiesa, contigua all'ospedale, dotata di tutte le suppellettili liturgiche al pari della altre chiese cittadine.
2. 1465: vengono costruite, al piano superiore dell'ospitale, due nuove camere dotate ciascuna di quattro letti e di due armadi.
3. 1490: riedificazione della chiesa di Santa Maria della Misericordia. L'intervento di ampliamento dell'edificio si protrarrà, a fasi alterne, per oltre un ventennio interessando anche il complesso dell'ospitale. La prima fase dei lavori è molto celere, tanto da consentire al vescovo di Reggio, monsignor Bonfrancesco Arlotti, di consacrare la nuova chiesa il 3 ottobre del 1491.
4. 1494: i confratelli acquistano quattro colonne di marmo per sostenere il nuovo porticato della facciata. Differentemente dall'attuale, il prospetto si presentava arretrato rispetto all'ospitale, con il fronte a capanna e una finestra circolare nel centro della facciata.
5. 1501: sono ultimati i lavori alla nuova sagrestia, ricavata nel vano dietro all'altare maggiore, dove ancora oggi si trova.
6. 1513: sono portate a termine le volte a crociera della chiesa. La tecnica costruttiva impiegata in Santa Maria, già in uso nella Correggio del tardo Quattrocento, prevede la realizzazione di volte a doppia camicia di muratura, con costoloni e rinfianco interno.
7. 1522-23: la confraternita fa erigere la nuova ancona dell'altare maggiore per inserire attorno alla quattrocentesca scultura della Madonna della Misericordia, le tre tele del Correggio componenti il Trittico della Misericordia divina .
8. 1573: i confratelli della Misericordia acquistano la casa confinante con l'ospitale, prospiciente su via Santa Maria. L'edificio, tuttora esistente, dal 1782 non fa più parte del complesso dell'ospitale.
9. 1575: per fare fronte alla crescente richiesta di ospitalità, viene acquistata anche la casa attigua alla precedente. L'edificio, tuttora esistente, dal 1782 non fa più parte del complesso dell'ospitale.
10. 1619: viene rifatto il presbiterio e risistemato il pavimento in cotto della chiesa.
11. 1699: la confraternita acquista un'altra casa, posta dietro la sagrestia. L'edificio, tuttora esistente, dal 1782 non fa più parte del complesso dell'ospitale.
12. 1695 - 1700: in questi anni è edificata la nuova facciata della chiesa di Santa Maria. L'antico portico in colonne di pietra è sostituito da una più solida struttura in muratura, composta da pilastri quadrangolari e volte a crociera a sostegno di un'ampia cantoria.
13. 1704: dalla relazione redatta in occasione della visita pastorale Picenardi si apprende che la chiesa, da oltre un secolo, era dotata di sette altari, ricavati all'interno del perimetro della chiesa ad eccezione del vano del presbiterio.
14. 1738: ha temine dopo quasi tre anni l'occupazione della chiesa da parte delle truppe francesi, lasciando pesanti danni agli altari e al pavimento. Furono approntanti diversi lavori di restauro che interessarono oltre al selciato interno e del sottoportico, il completo rifacimento di molti gli altari della chiesa tra i quali gran parte della cappella maggiore.
15. 1756 - 1758: tutto il complesso dell'ospitale è interessato da un nuovo grande intervento di restauro, finalizzato a ridonare funzionalità e "prestigio" alle vecchie strutture. L'autore dell'intervento è, probabilmente, l'architetto correggese Giorgio Magnanimi (1682-1775), allievo del Bibbiena.
16. 1761: si interviene sulle murature della sagrestia e della crociera del presbiterio. Tutti i nuovi ambienti vengono tinteggiati e decorati. Il selciato in cotto della chiesa viene rifatto interamente.
17. 1768- 1772: all'architetto Francesco Cipriano Forti (1713-1779) è affidato il completamento dei lavori di decorazione della sala delle Congregazioni e delle altre parti dell'ospitale.
18. 1771: viene rifatto l'intonaco della facciata della chiesa e risistemato il prospetto dell'ospitale su via Santa Maria.
19. settembre 1782: a seguito della soppressione della confraternita la chiesa e l'ospitale passano alla Congregazione di Carità di Correggio. La chiesa privata degli arredi sacri e degli altari è destinata a magazzino. L'ospitale, ridotto al solo nucleo originario, è chiuso e dato in affitto come privata abitazione.
20. 1795: grazie all'interessamento di un gruppo di devoti, nel mese di marzo iniziano i lavori di restauro della chiesa di Santa Maria. L'architetto correggese Filippo Cattania (1753-1813), è incaricato di dirigere il restauro che prevede la ricostruzione dell'altare maggiore e di due altari laterali posti nella seconda campata. Il vecchio pavimento in cotto del portico e della chiesa è sostituito da un battuto alla veneziana. Il 24 dicembre del 1796, il canonico Corrado Corradi, arciprete della collegiata di San Quirino, benedice solennemente la chiesa riaperta.
21. 1833: viene innalzata la nuova torre campanaria, coperta da una cupola in rame dal modenese Reggiani.
22. 1854: l'intero apparato decorativo interno ed esterno della chiesa è rinnovato dal pittore Andrea Capretti (1821-1870c.); all'architetto Forti, è affidato il ridisegno della facciata settentrionale della chiesa.
23. 1979: dopo anni di abbandono l'ingegnere Riccardo Bigi, per conto della parrocchia di San Quirino (succeduta alla pia unione nella proprietaria dell'immobile), progetta un intervento di rifacimento di consolidamento e deumidificazione della chiesa. Viene sostituita la copertura lignea con un tetto in latero-cemento sostenuto da 5 capriate metalliche triangolari ancorate a due cordoli in calcestruzzo armato. L'edificio viene sottoposto a "taglio meccanico"per bloccare l'umidità di risalita.
24. 1985: per bloccare l'umidità di risalita, l'edificio viene sottoposto a "taglio meccanico" delle murature; contestualmente viene rifatto il pavimento della chiesa sostituendo il battuto veneziano, completamente deteriorato dall'umidità, con una pavimentazione in cotto. L'intonaco esterno della chiesa, del sotto portico e delle parti interne alla chiesa ammalorate viene rifatto con malta bastarda (calce, cemento e sabbia).
25. 1996: a seguito del forte sisma del 15 ottobre, il complesso di santa Maria subisce notevoli danni tra i quali il parziale crollo della settecentesca volta della sala delle Congregazioni e il lesionamento delle logge interne del cortile e di una parte delle volte della chiesa. L'edificio viene puntellato nelle parti maggiormente danneggiate.
26. 2000: il 18 giugno un nuovo sisma, aggrava la situazione strutturale dell'edificio. Il Comune di Correggio con ordinanza del 21/06/2000, ordina l'immediata esecuzione di lavori di messa in sicurezza dell'immobile. La parrocchia di San Quirino, proprietaria dell'immobile, incarica lo studio Associato Gasparini di Reggio Emilia di progettare un primo intervento di consolidamento strutturale del portico di via Santa Maria. L'ingegnere Stefano Teneggiani esegue un intervento di cuci scuci all'estradosso delle volte completato da una cappa strutturale in conglomerato armato.
27. 2008: un nuovo sisma, di bassa entità, colpisce il 23 dicembre la provincia reggiana. Nella chiesa e nell'ospitale si aggravano alcune situazioni strutturali già compromesse dai precedenti terremoti. Il comune di Correggio con ordinanza del 30/12/2008 ordina di provvedere a nuovi lavori di messa in sicurezza dell'immobile. L'ingegnere Corrado Prandi di Correggio è incaricato dalla parrocchia di San Quirino di provvedere alla messa in sicurezza della chiesa. Viene puntellato l'archivolto del presbiterio e rinforzato l'appoggio di un setto murario in corrispondenza del portico.
INQUADRAMENTO STORICO
1.1 La Confraternita di Santa Maria della Misericordia in Correggio
1.1.1 Dalle origini del sodalizio alla soppressione ducale
Fra le numerose confraternite correggesi quella di Santa Maria della Misericordia è certamente la più antica benché, ad oggi, non si conosca la data di erezione. Rombaldi 1, ritiene fosse in attività "fin dal 1316" e correttamente relaziona la sua nascita con il movimento dei "flagellanti" che si diffuse in tutta Europa a seguito delle grandi pestilenze del Basso Medioevo.
Non a caso, come riporta Corradini nel suo studio sulla confraternita 2, le più antiche intitolazioni presenti nei documenti parlano di Hospitale Verberatorum de Corigia, oppure di Hospitale Sancte Mariæ Verberatorum in castro Corigia. Scarse, però, sono le fonti risalenti al XIV secolo, come pressoché inesistenti sono le informazioni sulla vita religiosa e caritativa del sodalizio nei suoi primi due secoli di vita. Sul finire del Trecento la confraternita era retta da due amministratori, ai quali, nel secolo successivo, sarà dato il nome di massari. Fedele al messaggio evangelico di fraternità, il sodalizio raccoglieva fra le sue fila aristocratici, notabili ma anche artigiani e gente umile, tutti profondamente mossi da una mistica tensione per la salvezza della propria anima, concretizzata nella preghiera comune, nelle celebrazioni di suffragio per i confratelli e per i benefattori defunti, oltre che nelle opere di misericordia, quali il conforto ai condannati "a morte", il soccorso degli indigenti e il sostentamento dell'infanzia abbandonata. Anticamente retta da un massaro, nel 1490, la confraternita riformò i propri statuti dotandosi di un priore e di un sindaco (vice-priore), assistiti da un massaro e da un fattore. Il carattere laicale dell'istituzione fu rimarcato dall'obbligo di eleggere gli ufficiali (priore, sindaco, massaro e fattore) fra i confratelli laici, escludendo quindi i membri del clero che venivano accettati nella congrega in veste di cappellani, necessari per la cura del culto e l'espletamento degli obblighi di suffragio del sodalizio.
Verso la metà del Cinquecento, per far fronte alla grande mole di lavoro che impegnava la confraternita, si decise di scorporare l'amministrazione in quattro parti.
Al priore fu affidato il compito di sovrintendere ai redditi derivanti dai beni immobili e dagli interessi fruttiferi oltre alla conduzione ordinaria della confraternita, al sindaco la gestione delle
1 Odoardo Rombaldi, Correggio Città e Principato, pp. 163-64.
2 Corrado Corradini, Per una storia delle confraternite laicali a Correggio - inventario dell'archivio di San Sebastiano e di Santa Maria della Misericordia, in Strenna Pio Istituto Artigianelli, Reggio Emilia 1988, p. 124.
spese correnti, al massaro l'amministrazione delle rendite derivanti dai servizi funebri che il sodalizio svolgeva, ed infine, al fattore fu affidata la cura degli esposti.
Un quadro generico dell'attività della confraternita, nella prima metà del Quattrocento, è fornito dalla Visita pastorale all'ospitale di Santa Maria in Borgovecchio, compiuta l'8 luglio 1439 da Francesco Fogliani, vicario generale della diocesi, per conto di monsignor Massolini vescovo di Reggio 3. Leggendo la relazione allegata emerge che la confraternita disponeva di una chiesa (contigua all'ospedale) dotata di tutte le suppellettili liturgiche al pari della altre chiese cittadine; il massaro, Francesco Frigeri, da quattro anni alla guida del sodalizio, viene indicato essere a perfetta conoscenza dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ospedale e in grado di garantire l'assistenza agli indigenti. Dunque una realtà stabile, ben inserita nel contesto sociale cittadino, tanto da estendere la propria opera a tutto il territorio della contea correggese.
A partire dalla metà del Trecento, numerosi lasciti avevano dotato la confraternita di terreni e abitazioni a Correggio, nelle ville di Mandrio, Rio, San Martino piccolo e Fazzano, e al Castellazzo di Campagnola, originando un cospicuo patrimonio indispensabile per il sostentamento dell'ospedale.
Il progressivo affermarsi nella vita correggese della confraternita della Misericordia, andò di pari passo con il consolidarsi del potere dei da Correggio sulla città; svanito il sogno di costruire un feudo unitario che inglobasse Parma, Guastalla e Castelnuovo Sotto, la Signoria decise di concentrale la propria azione politica e culturale su Correggio e sui territori circostanti 4.
Ne conseguì un forte impulso all'espansione della città, che comportò una riorganizzazione di tutto il tessuto urbano. Tra il 1360 e il 1380, Correggio fu cinta da una nuove mura, inglobando il quartiere del Borgovecchio, sorto un secolo prima a seguito dell'inurbamento delle popolazioni del contado.
Cuore pulsante della vita economica cittadina, il borgo era abitato da artigiani, conciatori di pelli, piccoli mercanti, vinai e osti, persone per lo più estranee alla vita pubblica della Correggio del Quattrocento che trovava in altri quartieri la sede per le proprie istituzioni.
Grazie alla sua posizione baricentrica e alla vicinanza con la porta di Santa Maria, l'ospedale divenne il principale polo di aggregazione del Borgovecchio tanto da trasformare la chiesa di Santa Maria della Misericordia da oratorio confraternale a chiesa di quartiere. Pur restando formalmente alle dipendenze dalla prevostura di San Quirino, alla quale spettava anche la nomina del rettore di Santa Maria, i fedeli del borgo si caratterizzarono per il culto alla Vergine, tanto da ospitare per
3 Archivio Memorie Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43, Origine della confraternita di Santa Maria. Si tratta della più antica visita pastorale alla confraternita della Misericordia di cui sia rimasta traccia documentaria.
4 Crf. Corrado Corradini, Per una storia .,cit., p. 125. Come scrive Corradini: "il fatto di trovare nel 1371 alla guida della confraternita una personalità come Guido Mondestri, rettore della chiesa di San Quirino, commendatario della chiesa di San Donnino di Fazzano ed appartenente ad una famiglia del contado dotata di prestigio politico, legata ai Da Correggio, è indice di un attento interesse con cui a Correggio si guardava al cresciuto ruolo della confraternita."
secoli l'unica chiesa cittadina dedicata alla Madonna5.
Per tutto il Quattrocento crebbe l'importanza della confraternita tanto che, nel 1490, con bolla del protonotario apostolico Luigi Capri, luogotenente generale del cardinale Ascanio Maria Sforza Visconti, Legato pontificio di Bologna, fu annesso all'Ospitale di Santa Maria della Misericordia, quello di San Bartolomeo, posto in prossimità del Ponte Mainardo nella villa di Fazzano6. L'annessione segnò un punto di svolta, non solo nell'attività assistenziale, aumentando il numero di indigenti soccorsi ma anche sotto l'aspetto devozionale, affiancando al culto della Vergine quello di san Bartolomeo apostolo, festeggiato ogni anno la mattina del 24 agosto con due Messe solenni, una in Santa Maria della Misericordia l'altra nell'omonimo oratorio, precedute da un triduo di preparazione. Anche la venerazione per san Giovanni Battista, patrono dei condannati a morte e dell'infanzia abbandonata, si era imposta nel corso del Quattrocento, probabilmente a seguito di un legato testamentario.
In questo clima di fervore religioso e di cristiana carità, nacque, si formò e visse Antonio Allegri detto il Correggio, membro di una delle tante famiglie mercantili e artigiane del Borgovecchio. Benché non sia provata una sua diretta adesione alla confraternita della Misericordia, mentre altri membri della famiglia Allegri compaiono fra i beneficiari dei suffragi di San Sebastiano7, è indubbio il legame che unì il Correggio alla chiesa di Santa Maria che, grazie ad una serie di fortuite coincidenze, fu il tempio correggese ad ospitare il maggior numero di sue opere. Verso la metà del Cinquecento, a seguito di nuovi flussi migratori provenienti dalle campagne, la densità del nucleo urbano crebbe ulteriormente, costringendo la confraternita a fronteggiare le numerose richieste di soccorso. La partecipazione delle più illustri famiglie di Correggio alla vita della confraternita, a partire dai da Correggio, fu un elemento fondamentale per la realizzazione delle opere del sodalizio, tanto che l'istituzione di legati e cappellanie continuò per tutto il Cinquecento e per gran parte del Seicento, manifesto segno di affezione dei ceti più abbienti alla Misericordia.
5 Crf. Corrado Corradini, Per una storia .,cit., p. 124-25.
6 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 44. Il culto a san Bartolomeo Apostolo, unitamente a quello per san Tommaso Becket fu introdotto nel 1176 dalla signoria dei da Correggio che avevano fatto dono ai sacerdoti della chiesa castrense di San Michele Arcangelo e Quirino di un terreno, sito in località ponte Mainardo, perché questi vi erigessero una chiesa ed un ospedale dedicati ai santi Bartolomeo Apostolo, Tommaso Becket e Quirino Vescovo. Crf Girolamo Tiraboschi, Memorie storiche modenesi col Codice Diplomatico modenese, III, Modena 1794, doc. n° CCCCLXVII, pp. 62-63, la costruzione dell'ospitale è erroneamente attribuita al 1173, mentre secondo gli studi effettuati da Corradini, è da posdatare al 1176 (vedi C. Corradini, Un culto in età moderna: la Madonna della Rosa di Correggio, in Ravennatensia XII, Atti del convegno di Fidenza 1983, Cesena 1989, p. 180).
7 Valter Pratissoli, I fratelli dalla cappa turchina: La Confraternita di San Sebastiano in Correggio edito dalla stessa confraternita nel novembre 1996. p. 25. Pratissoli scrive in notazione che i suddetti dati si ricavano ad annum da: Archivio Memorie Patrie, cartella 87, Libro di conti de le entrate di S.to Sebastiano e S.to Roccho administrate per me Iacopo Balbo et me Hieronimo di Silvestro Zuchardo (1541 e seguenti) e dall'Archivio Opere Pie, cartella 36, Libro dei conti dé massari della Confraternita di S. Sebastiano dal 1502 al 1637, conservati presso la Biblioteca comunale di Correggio (titolo apposto dall'archivista Cafarri).
Con Breve pontificio datato 23 marzo 1583 la confraternita ottenne l'aggregazione all'Arciconfraternita del Gonfalone di Roma8 che, oltre a valere come riconferma dell'erezione canonica, ne consolidò l'indipendenza dall'ordinario diocesano e aumentò il numero di indulgenze a disposizione del sodalizio correggese verso le quali indirizzare i bisogni spirituali degli affiliati e dei benefattori. In ossequio allo spirito del sodalizio che voleva tutti i membri "figli uguali" dinnanzi alla Madre Celeste, l'abito dei confratelli prevedeva, oltre alla cappa, il cappuccio; molto più di un semplice retaggio del passato di "battuti", il volto coperto era espressione dell'anonimato della carità e l'annullamento della vanità umana. A seguito di una disputa con le confraternite di San Sebastiano e della SS.ma Trinità attive in città nei medesimi ambiti caritatevoli, nel 1623 il vicario generale della diocesi, obbligò la confraternita di Santa Maria della Misericordia a cessare l'assistenza agli ammalati9, concentrando la propria attività verso l'assistenza degli esposti, tanto da sviluppare in pochi anni la più importanti struttura della bassa reggiana. Orfani, esposti e bambini indigenti erano inviati ai confratelli che inizialmente li alloggiavano all'interno dell'ospitale, per poi affidarli alle cure di famiglie locali di buon nome.
Il loro sostentamento era garantito dalla confraternita che semestralmente versava una quota alla famiglia ospitante, oltre a fornire il vestiario e quanto fosse necessario per l'educazione dell'esposto. Il priore compiva periodiche visite, così da accertarsi dello stato di salute e del livello di educazione del bambino dato in affido.
Anche le giovani ragazze in età da marito, ma prive di dote, trovavano assistenza e un concreto aiuto, così come i condannati a morte potevano contare sul conforto e sulla preghiera di suffragio degli "incappucciati" 10. Anche nella pratica religiosa la confraternita della Misericordia ebbe un ruolo centrale per la vita della città. Culmine dell'attività liturgica era la Settimana Santa ed in particolare la processione che la confraternita era solita organizzare il Giovedì Santo per le vie del borgo e la mattina della solennità del Corpus Domini, mentre nella Pasqua del 1564, per la prima
8 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46 II registro, Memoria sulle origini di Santa Maria. Al fine di ricomporre su base documentaria l'evoluzione della storia della confraternita e dell'ospedale in Santa Maria, risulta preziosa l'opera, rimasta manoscritta, cui è stato attribuito il titolo di "Memoria sulle origini di Santa Maria", di autore rimasto finora anonimo. Il testo, composto tra il 1765 e il 1770, si basa sulla trascrizione di notizie desunte da registri di carattere amministrativo o da atti notarili, risalenti al XV secolo, ed ancora posseduti nel Settecento dalla confraternita ed oggi andati perduti. È evidente, che pur con tutti i limiti che in sede di analisi storiografica una fonte indiretta comporta, il manoscritto rappresenti oggi la principale traccia per lo studio della confraternita.
9 ibidem. Nel manoscritto si fa anche cenno all'occupazione delle camere dell'ospitale, da parte delle truppe alemanne stanziate nel Principato in quegli anni. L'impossibilità di fornire un servizio decoroso, il dormitorio ormai spoglio e arredato con vecchi mobili, comportò l'abbandono della pratica infermieristica, da secoli svolta dalla confraternita.
10 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43. Nel documento è descritta con minuzie di particolari il rituale seguito in occasione del trasporto dal carcere al patibolo di un condannato a morte. La confraternita aveva cura sia dell'assistenza spirituale e materiale delle ultime ore del condannato sia di fornirgli degna sepoltura nell'ospitale e di far celebrare gli uffici di suffragio.
volta a Correggio, si tennero in Santa Maria le Sante Quarantore11.
Il culto alla Beata Vergine trovava ampio spazio nella vita del sodalizio: ogni domenica mattina si teneva la recita dell'ufficio della Madonna così il sabato al quale, dall'inizio dell'Avvento alla Pasqua, seguiva il canto delle litanie mariane. Piccole processioni erano organizzate in concomitanza con ogni festività mariana dell'anno, mentre era celebrata con particolare solennità la festa della Purificazione di Maria (2 febbraio), comunemente detta Candelora. Tale festa divenne col tempo la sagra del borgo, tanto da esser ancor oggi ricordata dagl'abitanti. Vi erano poi le celebrazioni legate ai lasciti o alla preghiera di suffragio per i defunti come la recita dell'ufficio nell'ottava dei morti.
Il Settecento vide la confraternita consolidare sempre più il proprio ruolo di istituzione assistenziale, ma i mutamenti politici e la presenza di truppe straniere nel Principato, da oltre cinquant'anni annesso ai domini estensi, furono alla base di un forte indebolimento del sodalizio. In soccorso dei confratelli arrivò nel 1709 l'ottenimento dalla Camera Ducale, del riconoscimento di ecclesiasticità, seguito nel 1726 dall'esclusione di tutte le proprietà dai libri di estimo12 che compensò le perdite dovute al calo delle rendite fondiarie e i forti esborsi per il mantenimento degli esposti e la quotidiana celebrazione delle messe di suffragio. Da una nota13 del sagrestano di Santa Maria datata 1725, si apprende che nella chiesa erano annualmente celebrate 2.928 messe, derivanti dalla sei cappellanie attive e da quelle officiate sull'altar maggiore.
La situazione si aggravò nel 1735, quando giunsero a Correggio truppe francesi che occuparono la chiesa trasformandola in un magazzino. Per oltre tre anni i confratelli furono costretti ad officiare in una cappella allestita, con non pochi problemi, al primo piano dell'ospedale nella camera delle Congregazioni14. Impossibilitati ad adempiere agli obblighi di suffragio, i confratelli si rivolsero al Vescovo di Reggio, monsignor Ludovico Forni, il quale li esentò dal rispetto dei legati, fino a cessata occupazione della chiesa. Ma le disavventure erano ben lungi dal passare. Nel 1750, fu eletto priore il nobile Antonio Cattania che fra notevoli difficoltà riuscì a portare a compimento i lavori di ristrutturazione di tutto il complesso confraternale, intrapresi nel 1738 all'indomani della riapertura al culto della chiesa15. Suo figlio Tommaso16 (Figura 1.4), divenuto priore nel 1770,
11 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46 II registro, Memoria sulle origini di Santa Maria. Nei successivi anni, questa pia pratica divenne appannaggio della confraternita del Corpo di Cristo, eretta ad inizio Cinquecento nella basilica collegiata di San Quirino, ma in virtù di aver dato inizio a tale devozione, la confraternita della Misericordia ottenne ugualmente, dai canonici di San Quirino, di ospitarla ogni tre anni in Santa Maria.
12 ibidem.
13 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43. Fino al 1735, in Santa Maria erano attive 7 "cappellania" che prevedevano la celebrazione di 340 messe annue ciascuna. Il numero delle messe celebrate è esorbitante, specialmente per una chiesa non parrocchiale; si tenga infine conto che la somma riportata dal sagrestano non calcolava le celebrazioni di precetto (domeniche e solennità) e dei numerosi servizi funebri effettuati dalla confraternita nell'arco dell'anno.
14 Meglio conosciuta come Sala della Congiura, l'appellativo deriverebbe da un avvenimento ivi accaduto il 29 marzo 1634, quando, a seguito dalla riunione segreta del Consiglio Generale del Principato, si deliberò l'allontanamento del principe Siro Da Correggio dallo Stato.
15 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46 II registro, Memoria sulle origini di Santa Maria.
arricchì la chiesa di nuovi arredi, ammodernando le camerate e le strutture di accoglienza degli esposti. In sostituzione dell'antico Gonfalone del sodalizio ormai logoro, fu acquistata, dall'ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio, una tela raffigurante la Beata Vergine della Misericordia, opera del pittore modenese Francesco Vellani (1687 - 1768)17. (Figura 1.3) Grazie alla conservazione di molti documenti settecenteschi, siamo in grado di ricostruire gli ultimi anni di attività dell'Ospitale anche nei minimi aspetti della vita quotidiana. Oltre al maneggio dei beni immobili e dei terrieri con le rispettive rendite, si sono salvate gran parte delle note di acquisto dei materiali edili impiegati nei lavori di ristrutturazione della chiesa, quelle delle per il mantenimento degli esposti o le spese per la sagrestia. Tra queste si sono salvati i mandati di pagamento per l'uva malvasia e per il vino da messa, direttamente acquistati dal sacerdote correggese don Antonio Nicolini che ne garantiva la conformità con le norme canoniche18. Ma i tempi erano ormai mutati: sulla spinta delle teorie illuministe molti stati europei avevano intrapreso una vasta serie di riforme dello stato sociale, dando vita alla pubblica assistenza ma a spese delle confraternite che nell'arco di pochi anni videro i loro beni incamerati nelle nuove istituzioni di carità e soppressi i loro oratori. Il 27 settembre 1782, per volontà del duca di Modena Ercole III d'Este, il conte Vincenzo Fabrizi, governatore di Correggio, soppresse la confraternita di Santa Maria della Misericordia, incamerandone i beni nella Congregazione di Carità19. Tutti gli arredi sacri furono messi all'asta e la chiesa, privata delle sue opere d'arte, chiusa al culto20. Anche l'oratorio di San Bartolomeo a Fazzano fu soppresso e, pochi mesi dopo, completamente demolito21. Per oltre un decennio la chiesa di Santa Maria fu ridotta a magazzino e gli annessi locali affittati come residenze private.
16 Tommaso Cattania, nacque a Correggio il 09 ottobre 1735 da Antonio e Ottavia Foresti. Nobile correggese, sposò nel 1765 la contessa Anna Maria Bettini di Carpi. Dal matrimonio nacquero Vincenzo e due femmine, Paola e Carlotta. Comandante delle truppe forensi di Correggio, come suo padre Antonio, fu Priore dal 1769 al 1772 della confraternita di Santa Maria della Misericordia. Rimasto fedele al suo sodalizio, anche a seguito della soppressione, operata nel 1782 da parte del Duca di Modena Ercole III d'Este, non cessò mai di svolgere l'attività di assistenza ai bisognosi, specialmente agli esposti. Nel 1796 la Comunità lo nominò Provvisore dei Conti, poi Vice Priore della stessa. Tommaso e la moglie Anna morirono nel 1803 a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro; per esplicita volontà del figlio Vincenzo, divenuto nel frattempo priore dell'Arciconfraternita del Ss.mo Sacramento, Tommaso fu sepolto all'interno del sepolcro dei confratelli del Sacramento, ancor oggi esistente all'interno dell'omonima cappella absidale della navatella sinistra della Basilica collegiata di San Quirino in Correggio.
17 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 44, busta 10. Sulla fine del Settecento la confraternita si trovò nella necessità di sostituire l'antico Gonfalone da tempo versante in pessimo stato, realizzato nel febbraio del 1600 dal ricamatore milanese Girolamo Pattucelli che, a sua volta, ne aveva sostituito uno più antico dipinto. A tale scopo il priore Tommaso Cattania, nel luglio del 1772, decise di acquistare per 7 Zecchini una tela raffigurante la Madonna della Misericordia e due confratelli oranti, di proprietà dell'Ospitale di S. Maria Nova detto degli Infermi, di Reggio Emilia. Il nuovo Gonfalone doveva avere notevoli dimensioni: sormontato da una grande croce dorata era sorretto da tre aste di legno, anch'esse dorate, dalle quali pendevano otto fiocchi di bavella gialla.
18 ibidem.
19 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 65, busta III, Congregazione generale dei luoghi Pii. Atti di protocollo (1781-1784). Notifica della soppressione della confraternita di Santa Maria della Misericordia e inventario dei beni; rogito datato 27 settembre 1782.
20.Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 65. 21 ibidem.
1.1.2 La rinascita ottocentesca: la Pia Unione dei Devoti di Santa Maria della Misericordia
Nell'ottobre del 1795, un gruppo di devoti alla Madonna della Misericordia, molti dei quali già membri della confraternita e capeggiati dal conte Vincenzo Gilocchi, cavaliere di Santo Stefano, ottennero dal Duca di Modena la riconsegna delle chiavi della chiesa ed il permesso di riaprirla al culto22. Per mettere a tacere le proteste dell'Opera Pia che da tredici anni era in possesso del fabbricato fu organizzata una sottoscrizione pubblica che raccolse influenti personalità della vita cittadina oltre a diversi sacerdoti, tra i quali il canonico Corrado Corradi, arciprete del Collegiata di San Quirino. Purtroppo la chiesa aveva subito pesanti danni dalle spogliazioni, ed in particolare la completa demolizione degli altari rendevano impossibile l'utilizzo. I lavori di restauro furono affidati all'architetto correggese Filippo Cattania (1753-1813), fratello dell'ex-priore Tommaso, ma l'improvvisa scomparsa del conte Gilocchi, rischiò di far naufragare il tutto23. Grazie alla generosità della famiglia Timolini e all'impegno di Francesco, nel frattempo nominato presidente unione di devoti, fu possibile completare i lavori di restauro. La Vigilia di Natale del 1796, l'arciprete Corrado Corradi, a nome del Vescovo di Reggio e fra le lacrime di gioia dei tanti correggesi accorsi ad assistere, benedì solennemente la chiesa riaperta24. Si cercò di recuperare, per quanto fosse possibile, gli antichi arredi della chiesa, un tempo adornata da sette altari, e di dotarla dei nuovi paramenti per le celebrazioni liturgiche25. Fu recuperato il Gonfalone ed altre tele di piccole dimensioni, acquistate all'epoca della spogliazione dalle stesse famiglie iscritte alla confraternita. Il 24 settembre 1797, con grande concorso di popolo, fu solennemente riportata nella chiesa la quattrocentesca statua della Madonna della Misericordia, per l'occasione riassemblata dagli apparatori Antonio Malaguzzi e Giuseppe Boselli26. (Figura 1.5) L'immagine era stata acquistata all'asta da Domenico Timolini, padre di Francesco, e donata a sua figlia, suor Giacinta clarissa di Santa Chiara, la quale di buon grado la restituì ai fedeli per riportarla nella sua chiesa. La semplice associazione di devoti si costituì in Pia Unione, dotandosi di uno statuto che prevedeva l'elezione di tre presidenti, ordinariamente in carica per un anno, ma riconfermabili più volte27. Furono anche nominati un sagrestano, un cancelliere, un cassiere e scelto un sacerdote quale cappellano della chiesa. La Pia Unione di Santa Maria della Misericordia, erede
22 Archivio Memorie Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 86.
23 Archivio Memorie Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 154, Memorie (1794 -1823) di Pietro Vellani, alle date suddette.
24 ibidem.
25 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46 II registro, Memoria sulle origini di Santa Maria.
26 Archivio Memorie Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 154, Memorie (1794 -1823) di Pietro Vellani, alle date suddette. Per approfondire si rimanda a: La Madonna di Santa Maria della Misericordia in Correggio, edito nel 2004 a cura della parrocchia dei santi Quirino e Michele Arcangelo.
spirituale della soppressa confraternita, ripristinò il tradizionale culto alla Vergine, con particolare attenzione alla festa della Purificazione di Maria (2 Febbraio), ma decaddero completamente la devozione a san Bartolomeo e a san Pietro, sostituite da quella per san Biagio. Cessarono anche gli antichi legati e la Pia Unione si limitò alla celebrazione di due Messe di suffragio per ogni sodale e benefattore defunto, oltre alla recita dell'ufficio funebre durante l'ottava dei morti. La scelta di costituire una Pia Unione anziché di ripristinare l'antica confraternita, evitò un'ennesima soppressione, all'indomani dell'editto della Repubblica Cisalpina (1798) che prevedeva l'incameramento dei beni e l'immediata chiusura di tutte le confraternite e degli istituti religiosi. Per tre lustri, dal 1799 al 1815, la Pia Unione fu retta dal nobile Giuseppe Rossi Foglia, il quale portò a compimento l'opera di ricostruzione del sodalizio iniziata dal Timolini28. Con la definitiva sconfitta di Napoleone e la Restaurazione, il sodalizio rientrò in possesso di alcuni antichi privilegi della confraternita, in particolare quelli di natura fiscale, che permisero agli amministratori di proseguire nella campagna di restauri. La Pia Unione di Santa Maria della Misericordia rimase attiva fino agli anni Quaranta del Novecento, proseguendo la sua opera di devozione alla Madonna, come previsto dallo statuto. L'avvento di nuove forme di aggregazione, nel panorama cattolico nazionale e locale, tolsero l'interesse dei fedeli verso una simile associazione, condannando la Pia Unione ad un lento esaurimento.
1.2 La chiesa e l'ospitale di Santa Maria della Misericordia in Correggio: storia e architettura
La complessità architettonica di Santa Maria della Misericordia e la completa mancanza di documenti antecedenti al XV secolo, ci impongono la massima accortezza nello sviluppare ipotesi sui primi secoli di vita dell'oratorio, il più antico dedicato alla Vergine presente in città29. La prima testimonianza documentaria, che ne attesta l'esistenza nel Borgovecchio, è contenuta nella la già menzionata visita Fogliani, del luglio 1439; dall'inventario emerge che la chiesa era dotata di tutte le suppellettili liturgiche necessarie per il culto fra cui un calice d'argento con piede di rame, una patena d'argento, due messali, due paliotti d'altare, due pianete e diversi candelieri. Sfortunatamente la cronaca non si sofferma a descrivere l'oratorio, né fornisce un elenco degli altari presenti nella chiesa, ma si limita a riportare la dedicazione della cappella maggiore alla Madonna
27 Archivio Memoria Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 86, Statuti delle Pia Unione di Santa Maria della Misericordia.
28 Cenni Storici sulla Pia Unione di Santa Maria della Misericordia di Correggio, Modena Tipografia Capelli, 1859, pp. 5-7.
29 Crf. Corrado Corradini, Per una storia .,cit., p. 124-25.
della Misericordia. Ma che forma aveva l'antico oratorio di Santa Maria? La risposta non è certo facile: probabilmente si trattava di un oratorio di dimensioni modeste, con un'unica navata e un solo altare. Se si studiano le tracce murarie, ancor oggi presenti in più parti della chiesa e dell'ospedale, è possibile immaginare che il primitivo oratorio avesse un diverso orientamento. Infatti, stando alle norme liturgiche in vigore fino agli inizi del Cinquecento, tutti gli edifici religiosi dovevano avere l'abside ad oriente, così da convergere la preghiera dei fedeli in direzione del "Signore che viene". Questa ipotesi porterebbe ad un rovesciamento delle parti della chiesa rispetto all'attuale conformazione, con l'antica abside posta in corrispondenza del portico e la facciata rivolta verso ovest, in asse con il secondo tratto di via Borgovecchio. Molto probabilmente si trattava di un oratorio di dimensioni modeste, con un'unica navata e un solo altare. Sul finire del Trecento, Correggio fu cinta di nuove fortificazioni che inglobarono il Borgovecchio all'interno del nucleo urbano. L'apertura di Porta di Santa Maria, posta a pochi metri dall'ospitale, sviluppò una nuova direttrice (nord-sud) che riorganizzò l'intero quartiere, spostandone il baricentro nel punto d'intersezione fra le due vie. (Figura 1.7) Similmente ad altri quartieri della città, dove piccoli slarghi delle contrade si trasformarono in "piazzette", così il Borgovecchio vide nascere la sua "piazza" sul lato settentrionale di Santa Maria. Questo nuovo assetto urbano determinò notevoli trasformazioni alla chiesa, ridefinendo i prospetti oltre all'apertura di un ingresso in corrispondenza della piazzetta. Una conferma è riscontrabile osservando l'ultima campata prima del presbiterio sul lato settentrionale, dove, a seguito del distacco dell'intonaco, sono riemerse le tracce di una porta murata e gli sguinci di una finestra tardo gotica. Altri segni sono rintracciabili nelle murature del sottotetto ed in quelle del setto che separa la chiesa dell'ospedale. Anche il cortile interno conserva parti dell'antico porticato a due ordini, probabilmente realizzato nella prima metà del Quattrocento. Nel 1465 su proposta del conte Manfredo da Correggio, confratello di Santa Maria della Misericordia, furono costruite, al piano superiore dell'ospitale, due nuove camere dotate ciascuna di quattro letti e di due armadi30. L'intervento non fu che un rimedio temporaneo, infatti, già nel 1490 tutto il complesso fu interessato da un nuovo cantiere che portò alla costruzione di una nuova chiesa, in grado di accogliere i numerosi fedeli che giornalmente vi si recavano per pregare. I lavori dovettero procedere molto celermente tanto da consentire al Vescovo di Reggio monsignor Bonfrancesco Arlotti, di consacrarla il 3 ottobre dell'anno successivo31. Visti i tempi ristretti, non si trattò della ricostruzione ex-novo di tutta la chiesa, ma piuttosto dell'ampliamento dell'antico edificio. Furono rafforzate tutte le murature perimetrali, rifatta la copertura e orientato l'edificio verso ponente, collocando la nuova facciata su via Santa Maria.
30 Archivio Memorie Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 86.
Per conferire maggiore stabilità alla chiesa, il lato settentrionale fu in più parti riedificato inserendo, nei punti dove il terreno era più cedevole, robusti archi di scarico. I lavori proseguirono fino al 1494, quando i confratelli acquistarono quattro colonne di marmo per sostenere il porticato della nuova facciata32, completato l'anno seguente insieme al selciato. Il portico, a tre fornici, era coperto da un semplice tetto in coppi spiovente verso la strada; la facciata, arretrata di alcuni metri rispetto l'allineamento del caseggiato, era a "capanna" sormontata da un timpano triangolare con guglie33. Nel 1501 fu costruita la una nuova sagrestia, ricavata dietro l'altare maggiore, mentre nel 1513 furono ultimati i volti della chiesa34. L'aula fu coperta da tre crociere a sesto ribassato, composte da una doppia camicia di muratura con costoloni interni che determinano, oltre ad un notevole spessore, un elevato peso tanto da rendere necessaria la costruzione di quattro robusti archi di contrasto. Molte importanti opere arricchirono negli anni la chiesa, fra le quali cinque opere di Antonio Allegri detto il Correggio (1489-1534). Di questo considerevole corpus di opere, certamente, il Trittico (Figura 1.9) rappresentava la più ragguardevole. Realizzato intorno al 1522-23 per l'altare maggiore della chiesa, allo scopo di costituire una ampia struttura, in grado di inglobare e riqualificare l'antica statua in terracotta della Madonna della Misericordia35, attribuita a Desiderio da Settignano (1430-1464), il Trittico si componeva di tre dipinti: una tela sommatale raffigurante un Cristo-Dio in gloria (Figura 1.10) e due laterali con le figure di San Giovanni Battista e San Bartolomeo apostolo. Rodolfo Papa nel suo recente saggio36 fornisce una preziosa e dirimente lettura iconologia sul rapporto che legava le tre tele alla scultura mariana, rinominando la deesis come il Trittico della Misericordia divina, rileggendo l'apparato iconografico come una manifestazione della pietà cristiana che scaturisce dal seno del Padre e attraverso la mediazione di Maria e dei santi patroni del sodalizio (Giovanni Battista e Bartolomeo apostolo), viene riversata sui fedeli. Per l'amico Melchiorre Fassi, confratello della Misericordia, l'Allegri dipinse una tela raffigurante i santi Pietro, Marta, Maria Maddalena e Leonardo, comunemente chiamata i Quattro Santi. Il quadro, inizialmente destinato alla chiesa di Santa Maria, fu oggetto di una lunga e controversa vicenda testamentaria che si risolse solamente nel 1538, con la nomina della confraternita quale unico erede
31 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46, II registro. Memoria sulle origini di Santa Maria.
32 ibidem.
33 Un idea abbastanza attendibile, benché approssimativa, del prospetto cinquecentesco ci è fornita dalla pianta della città di Correggio (1620 circa) conservata presso il Museo Civico. Nella raffigurazione la chiesa mostra il fronte leggermente arretrato rispetto l'attuale e sormontato da un timpano con pennacchi.
34 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46, II registro, Memoria sulle origini di Santa Maria.
35 Si veda a riguardo l'importante saggio di Valter Pratissoli, La Madonna della confraternita di Santa Maria della Misericordia in Correggio nelle testimonianze storiche locali, in La Madonna di Santa Maria della Misericordia in Correggio, edito nel 2004 a cura della parrocchia dei santi Quirino e Michele Arcangelo.
36 Si veda a riguardo l'importante saggio di Rodolfo Papa, Lettura iconologia del Trittico, in Il Correggio a Correggio, protagonisti e luoghi del Rinascimento, catalogo dell'omonima mostra tenutasi a Palazzo Principi dal 4 ottobre 2008 al 26 gennaio 2009, pp. 124-143.
e la tela sistemata nell'altare della famiglia Fassi37. Nel 1547 fu commissionata all'orafo Ettore Donati di Mantova la nuova croce d'argento per l'altare maggiore mentre, nel 1567, furono acquistate due nuove campane e rifatti i parati da messa38. Probabilmente sul finire del Cinquecento fu trasferito nel primo altare a sinistra dell'ingresso, l'affresco raffigurante la Madonna con il Bambino e i Santi Quirino e Francesco, anche detto Madonna dei limoni (Figura 1.11), realizzato dal giovane Correggio forse per l'antica Porta di Santa Maria, chiusa, nel 1557, a seguito del riordino del sistema difensivo cittadino39. Per far fronte alle crescenti richieste di assistenza, la confraternita acquistò nel 1573 la casa, prospiciente via Santa Maria, di proprietà del nobile Paolo Zuccardi e, due anni dopo, anche quella attigua di Vincenzo Brunorio. Lo sforzo economico apparve da subito elevato rispetto le esigue risorse del sodalizio e nel 1578, il conte Giberto XI da Correggio priore della confraternita, si fece promotore, congiuntamente ai due condomini dello stato ed ai rappresentanti delle più illustri famiglie della comunità cittadina, della realizzazione delle nuove strutture dell'ospedale. In soli due anni fu portato a compimento l'ammodernamento di tutto lo stabile, aumentando il numero delle camere e dei posti letto a disposizione degli esposti e degli ammalati40. Otto anni prima la contessa Claudia Rangone, moglie di Giberto, aveva donato all'altare della Madonna della Misericordia preziosi ornamenti in cuoio lavorato, contribuendo ad incrementare la dotazione di suppellettili liturgiche della sagrestia. Nell'inventario dei beni redatto nell'ottobre del 1598 si legge che la
37 David Ekserdjian, Correggio, Silvana Editoriale 1997, pp. 54-56; Elio Monducci, Il Correggio, la vita e le opere nelle fonti documentarie, Silvana Editoriale 2004, pp 54-67; Maddalena Spagnolo, in Correggio e l'antico, catalogo dell'omonima mostra, Roma 2008, p. 92, n. 4.
38 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46, II registro, Memoria sulle origini di Santa Maria.
39 Benché esista una consolidata tradizione che vuole il dipinto provenire dall'antica chiesa di San Quirino in castello, l'assoluta assenza di documenti o di riferimenti coevi sicuri, oltre alla scelta dei santi raffigurati (titolari delle due principali chiese della Correggio del primo Cinquecento), favoriscono la formulazione di una nuova ipotesi d'origine: la provenienza dell'affresco dalla vicina porta di Santa Maria, chiusa nel 1557 a seguito del riordino del sistema difensivo cittadino30. A favore di questa teoria vi è l'iconografia stessa della scena: la dedicatio urbis della città di Correggio, rappresentata nel modello offerto dal patrono san Quirino, vescovo e martire, affiancato da san Francesco d'Assisi, alla protezione della Vergine e del Bambino, ritratta seduta con il divin Figlio in grembo secondo il modello che potrebbe esser stato ispirato della statua della Madonna della Misericordia.
40 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43, Convenzione per la fabbrica dell'ospedale e chiesa, nota di spese. L'interesse di questo documento, già citato da Corradini nel suo studio sulla Confraternita di Santa Maria, non è soltanto di carattere "paleografico", in quanto raccoglie molte sottoscrizioni autografe di importanti personalità correggesi, quanto piuttosto di carattere propriamente storico. Il documento, oltre all'elenco degli obblighi dei sottoscrittori, riporta con minuzia il costo, la quantità e la provenienza dei materiali impiegati per la costruzione delle nuove camere dell'Ospitale di Santa Maria. Inoltre, attraverso l'individuazione dei firmatari e della loro posizione sociale, si desume un quadro abbastanza completo delle relazioni tra la confraternita e i membri delle famiglie correggesi e della loro partecipazione alla vita dello stesso sodalizio. Ad una prima lettura delle sottoscrizioni si segnalano i nomi di Simone Zaccarelli, già arciprete di San Faustino di Rubiera e vicario generale della diocesi di Taranto per conto del cardinale Girolamo Da Correggio; di Flaminio Brunorio, futuro segretario del Principe Siro e vicario foraneo in quegli anni; di Giulio Leprotti rettore della chiesa sub urbana di San Giovanni Battista; di Francesco Astolfi, eletto fra gli Anziani della città; del notaio Ottavio Schiattarini priore della Confraternita di Santa Maria della Misericordia. Occorrerebbe svolgere un'analisi particolareggiata su questo documento, i cui risultati dovrebbero rivelarsi estremamente interessanti a proposito della "religione cittadina".
chiesa era in possesso di molte suppellettili tra le quali, quadri cioè pitture di Nostro Signore della Madonna in tutto compresa una di rilievo n°541. Il riferimento al Trittico e alla statua della Madonna della Misericordia è palese, mentre più incerto è quello alla tela dei Quattro Santi e all'affresco trasportato della Madonna presso la porta anche detta dei limoni42. La costante necessità di reperire fondi per sostenere le ingenti spese di gestione dell'ospitale, spinse i confratelli ad assecondare i desideri del principe Giovanni Siro da Correggio d'Austria (1590-1645), cedendogli le tele componenti il Trittico del Correggio43. Nel marzo del 1613 le tre tele furono rimosse dall'ancona e consegnate al principe; al loro posto furono eseguite delle copie di inferiore qualità che, oltre a privare la chiesa di un eccezionale tesoro, alterò l'armonico rapporto istauratosi fra i quadri e la statua della Madonna. Gli originali presero la volta di Mantova dove furono dispersi in collezioni private. Nel 2008 nell'ambito della mostra correggese dedicata all'Allegri è stata riconosciuta dal comitato curatore l'autografia della tela raffigurante il Creatore sull'iride tra angeli, già cimasa del Trittico, ed oggi conservata nella Pinacoteca Vaticana. Coi fondi raccolti dalle alienazioni e dal pagamento anticipato dei legati, nel 1619 la confraternita decise di rifare il presbiterio e di sistemare il pavimento della chiesa che in più
41 Il documento, conservato presso l'Archivio Storico Diocesano, riporta che il Vicario Generale diede l'ordine al priore di rimuovere e vendere gli altari portatili incassati nella mensa,così da fronteggiare le ingenti spese della confraternita.
42 Probabilmente sul finire del Cinquecento fu trasferito nel primo altare a sinistra, l'affresco raffigurante la Madonna con il Bambino e i Santi Quirino e Francesco, anche citato nei documenti con il nome di Madonna della porta, realizzato dal giovane Correggio forse per l'antica porta di Santa Maria, chiusa, nel 1557, a seguito del riordino del sistema difensivo cittadino. Per via della presenza alle spalle dei personaggi di una folta siepe, carica di grossi agrumi, la tradizione locale lo ricorderà anche con il titolo di Madonna dei limoni, nome ancor oggi utilizzato dagli studiosi per identificare l'opera.
43 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43. Lettera del Vescovo monsignor Claudio Rangone agli ufficiali della confraternita nella quale l'ordinario diocesano ordina, pena l'incorrere nelle sanzioni canoniche di esibire il permesso avuto da Roma di poter togliere dall'altar maggiore della loro chiesa il Trittico (1613). Archivio Memorie Patrie, Biblioteca Comunale di Correggio, cartella 113, Antonio Allegri, Documenti bibliografici e notizie storiche, su foglio sciolto con grafia di Michele Antonioli è ricopiato un estratto del libro mastro della Confraternita di Santa Maria della Misericordia, oggi perduto, dove il massaro riporta nel dettaglio la vendita dei tre quadri al principe Siro ricordando di ave ricevuto le debite autorizzazioni del Vescovo di Reggio e di Roma e di aver sostituiti gli originali con copie. Sul medesimo foglio, con medesima grafia ma in un successivo momento sono riportate le misure in braccia correggesi delle tre tele. Ovviamente si trattano delle misure delle copie che trovarono posto nell'ancona, negli spazi lasciati liberi dagli originali. Ipotizzando che il braccio utilizzato fosse quello agrario pari a 53 cm. e che ogni braccio era diviso in 12 once pari a circa 4,42 cm., le dimensioni dei quadri risulterebbero: Umanità di Cristo o Ascensione, alta braccia 2, larga braccia 1 e once10 (106 x 97 cm. circa); San Giovanni Battista e San Bartolomeo Apostolo alta braccia 2 e once 10, larga braccia 1 (152 x 53 cm. circa). Di conseguenza è ipotizzabile che la nicchia centrale contenente la Madonna della Misericordia fosse alta quanto un laterale e larga circa come il quadro superiore (152 x 96 cm.). La trattativa ebbe inizio nel dicembre del 1612 con il sopralluogo in Santa Maria del pittore Jacopo Borbone di Novellara, inviato da don Siro d'Austria all'epoca conte di Correggio a epertizzare le tele. Il 6 marzo del 1613 durante la vistia pastorale di monsignor Claudio Rangone, vescovo di Reggio, dopo aver rilevata l'abusisva sostituzione degli originali diede ordine affinché tutto come in precedenza. Iniziò un duro contenzioso fra il vescovo e i confratelli della Misericordia determinati a cedere le tele a Siro. L'opposizione di monsignor Rangone fu rimossa solamente ain seguito all'intervento diretto della Camera Apostolica ed in particolare del cardinale Scipione Borghese, all'epoca prefetto del Tribunale della Segnatura. Il 20 novembre 1613 con lettera indirizzata al dottore Ettore Donati, priore di Santa Maria della Misericordia, il vescovo di Reggio forniva il proprio assenso alla vendita, avvenuta tre giorni dopo alla presenza del notaio Paolo Camillini di Correggio e degli Ufficiali della confraternita di Santa Maria, Siro acquistò le tre tele al prezzo di 300 ducatoni d'oro da lire 8, versati alla confraternita in tre rate annuali all'interesse dell'8% annuo. Al posto
punti era sfondato. Nonostante la perdita di tre opere del Correggio, Santa Maria fu arricchita da nuovi altari, frutto di importanti lasciti di devoti e dell'istituzione di ben sei cappellanie di suffragio. Dalle indicazioni contenute nella seicentesca Nota delli altari et sacrestia 44 e nell'inventario dei beni redatto nel 1704 in occasione della visita Picenardi45 alla chiesa, è possibile ricostruire l'antica disposizione degli altari di Santa Maria. Partendo dal fondo della chiesa sulla parete di sinistra, il primo altare che si incontrava era quello della Madonna presso la porta, seguito da quello del Crocefisso (in seguito dedicato a Sant'Anna) 46, e dal celebre altare di Santa Marta, di proprietà della famiglia Fassi47. Sulla parte opposta il primo altare, verso il presbiterio, era quello di San Carlo Borromeo (già di San Pietro Martire) 48, seguito da quello di San Giovanni Battista49 e
degli originali furono definitivamente poste le copie di inferiore qualità, realizzate mesi prima probabilmente dallo stesso Borbone, alterando l'armonico rapporto studiato dal Correggio fra i quadri e la statua della Madonna.
44 Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, chiese e parrocchie, filza 91. "Correggio" (confraternite, ospedali, ecc..). La Nota delli altari et sacrestia et oblighi della chiesa di Santa Maria riporta fedelmente la dedicazione degli altari della chiesa. Il testo è stato in parte riprodotto in M. Pirondini - E. Monducci, La pittura del Cinquecento a Reggio Emilia, Milano 1985, p. 250. Si tratta quasi certamente di una descrizione fatta in preparazione di una visita pastorale non identificabile con sicurezza, presumibilmente databile intorno al 1621-22 (Crf. Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia Sacre visite Pastorali. Filza 3-4, Liber primis visitatiorum del cardinale Alessandro d'Este, 1622-1623; visita a santa Maria: 31 ottobre 1622, cui segue la visita di Paolo Coccapani, 1625-1635; visita a Santa Maria: 21 novembre 1628) . Questo documento, che Elio Monducci ha datato tra Cinque e Seicento, è stato ritenuto probante della presenza sull'altare maggiore dei dipinti costituenti il Trittico della Misericordia del Correggio, ma come dimostrato da Valter Pratissoli si riferisce in realtà alle copie che sostituirono gli originali, acquistati nel 1613 da don Siro d'Austria da Correggio (Crf. V. Pratissoli, La Madonna della confraternita di Santa Maria della Misericordia in Correggio nelle testimonianze storiche locali, in La Madonna di Santa Maria della Misericordia in Correggio, Correggio 2004, p. 77). Stando a quanto scrive Pratissoli, l'elemento che postdaterebbe la Nota è costituito dalla denominazione del quarto altare a san Pietro Martire con la seguente precisazione: et questo altare hora si ritrova sfornito perche la Compagnia la datto ad un particolare che fa fare il quadro a Bologna. La nuova assegnazione comportò una diversa intitolazione dell'altare a san Carlo Borromeo, conservando tuttavia la memoria iconografica della precedente, Nuovo patrono dell'altare divenne il mercante Orazio Capretti (Archivio Storico Notarile di Correggio, busta 655. notaio F. Torricelli, filza IV, rogito del 6 luglio 1630; testamento di Orazio Capretti: il testatore chiedeva di essere sepolto presso l'altare di San Carlo in santa Maria da lui stesso eretto). Inoltre alla fine della Nota, si specificava che, per soddisfare gli obblighi delle messe, officiavano sette cappellani: questi erano ancora sei nel 1618, ma già sette nel 1625 (Crf. Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia Sacre visite Pastorali. Claudio Rangone. Filza 5: Visitationes annis 1618; c[33] verso. Cfr. inoltre Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43: Spesa fatta l'anno 1625 dal sindaco: lire 1708 «in sette cappellani»). Alla luce di questi e dei precedenti riferimenti la Nota delli altari assegnata dal Monducci al Cinque Seicento e dal Ciroldi al 1655 ca. o al 1652 (I dipinti di Antonio Allegri nella chiesa di Santa Maria della Misericordia di Correggio, in La Ricerca storica locale a Correggio. Bilanci e prospettive. Correggio 2004.), deve essere datata sicuramente dopo il 1614 e prima del 1630.
45 Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Sacre visite pastorali. Visita Picenardi 1702-1704; Filza 16, fasc. "Correggio": De oratorio S. Marie Misericordie Corrigli, die 25 augusti 1704.
46 ibidem. Nella descrizione allegata alla visita pastorale si ricorda che nel quinto altare, dedicato a Sant'Anna venivano celebrate alcune messe a carico degli eredi di Giovani Affarosi. Questi fece testamento nei giorni 21 e 22 e morì il 23 agosto 1614 (cfr. Archivio Storico Notarile di Correggio, busta 202, notaio P. Capellini, filza IX, rogiti nn. 124 e 125; Archivio parrocchiale di San Quirino, Libro dei morti, 1592-1630). Tutta l'eredità Affarosi confluì in Gabriele, morto nel 1630 (cfr. Archivio Storico Notarile, busta 655 notaio F. Torricelli, filza IV, rogito 6 novembre 1630:divisione dei beni di Gabriele Affarosi tra privati e confraternite di Santa mAria e Santissima Trinità).
47 Il medesimo altare, dalla fine del XVII secolo, è indicato col titolo "di San Pietro". Probabilmente la nuova denominazione fu determinata da una maggiore devozione al Principe degli apostoli (raffigurato nella pala assieme ai santi Marta, Leonardo e Maria Maddalena) che però non cancellò il culto a santa Marta, in onore della quale si continuò a celebrare il 29 luglio una solenne messa in canto.
48 Dalla citata cronaca della vista Picenardi, del 1704, l'altare di San Carlo risulta ancora patronato di un Capretti, Alessandro. Quanto alla pala, che però non è descritta accuratamente, viene avanzato il nome del probabile autore: Icona est celeberrimi Gipsi. L'assegnazione a Francesco Gessi (Bologna 1588 - 1649) verrà poi raccolta dall'Oretti; tuttavia l'opera risulta oggi tra quelle ricordate dalle fonti ma irreperibili o perdute: Correggio. Chiesa della
dall'altare delle Sante Lucia ed Agata50. Altrettanto generose furono le donazioni per l'altare maggiore tanto che, nel 1652 i confratelli fecero indorare l'ancona al cremonese Andrea Spada e nel 1669, il confratello Francesco Righetti donò alla Madonna della Misericordia, una lampada d'argento recante la sua arma51. Nel 1689 furono eseguiti dal correggese Marco Bianchi (1636-?), nel sottoportico esterno ai lati della porta d'ingresso, due pitture raffiguranti l'Annunciazione e la Natività, oggi completamente scomparse52. Due anni dopo, il capomastro Clemente Merli, fu chiamato ad eseguire diverse opere di manutenzione sulla chiesa e sull'ospedale. Furono sostituiti i "piatti" in pietra alla base delle colonne del portico, imbiancata la facciata, rimesse le cornici all'altare maggiore, rifatto il pavimento del presbiterio e riparati i gradini della cappella del Crocifisso, rifatto il tinteggio della sagrestia, sostituiti i coppi rotti del campanile e della chiesa. Altri lavori furono eseguiti nelle cucine dell'ospitale, nelle camere da letto e nel cortile, oltre al ricoprimento della fogna53. Il crescente numero di bambini "esposti", costrinse la confraternita ad acquistare nel 1699 un'altra casa, di proprietà del nobile Paolo Francesco Grillenzoni, posta dietro la sagrestia lungo via Borgovecchio54, estendendo l'intero complesso dell'ospitale a buona parte dell'isolato intorno alla chiesa, senza contare le singole abitazioni poste nel quartiere e utilizzate come case di prima accoglienza per i bambini e per gli indigenti. Negli stessi anni, sul modello della chiesa di San Sebastiano, fu costruita la nuova facciata di Santa Maria, sostituendo l'antico portico a colonne di pietra con una più solida struttura in muratura, composta da pilastri quadrangolari e volte a crociera a sostegno di un'ampia cantoria. Dell'antica
confraternita di Santa Maria. San Carlo Borromeo e San Pietro Martire (Oretti, Ms, 128 c 77); cfr E. Negro, Francesco Gessi, in La scuola di Guido Reni (a cura di M. Pirondini - E. Negro), Modena 1992, p. 249. Dalla visita Forni apprendiamo che oltre ai santi Carlo Borromeo e Pietro martire vi era raffigurata anche la Madonna (cfr. Archivio Curia Vescovile di Reggio Emilia, Sacre visite pastorali, Forni Ludovico, 1724-1729. Filza 22) .
49 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46, II registro. La tradizione attribuiva questa pala al figlio del Correggio, Pomponio Allegri.
50 Francesco Cafarri, Dieci secoli di storia dei Luoghi Pii di Correggio dall'anno 950 al 1920, dattiloscritto presso la Biblioteca Comunale di Correggio, senza collocazione. Dallo stesso testo è stata ricavata una Breve memoria sugli ospedali di Correggio (1173 - 1922), dattiloscritto conservato presso la Biblioteca Comunale di Correggio con collocazione «20.4.32». Secondo quanto scrive Cafarri, il quadro raffigurante le sante Lucia e Agata e la Beata Vergine Maria, fu dipinto nel 1652 da un figlio del nobile Alberto Guzzoni. Nella visita pastorale del vescovo Ludovico Forni, al quadro risulta aggiunta la figura di San Biagio vescovo e martire.
51 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46, II registro. Francesco Righetti fu priore della confraternita di Santa Maria della Misericordia dal 1632 al 1640 circa. Durante il suo mandato la confraternita portò a termine i lavori di restauro dell'ospitale di San Bartolomeo a Fazzano, intrapresi dal suo predecessore, il nobile Ubertino Zuccardi.
52 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46, II registro. Le scarse e non sempre attendibili informazioni, ad oggi in nostro possesso, sulla vita e sulle opere di Marco Bianchi ci sono fornite dalle Biografie di illustri correggesi scritte da Ernesto Setti e dall'opera di Quirino Bigi intitolata Notizie di Antonio Allegri, di Antonio Bartolotti suo maestro e di altri Pittori ed artisti correggesi. Vedi anche Gianluca Nicolini, La "confessio" della città di Correggio davanti ai santi Patroni, in Correggio Produce 2006, pp. 100-101.
53 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43.
facciata si salvarono solo il portale e le murature del sottoportico con i dipinti del Bianchi, mentre della parete superiore, dovendo far posto al grande archivolto della cantoria, non rimase nulla. Pur non conoscendo il nome del progettista, è facile intuire il desiderio di mimetizzare il nuovo prospetto con il resto dell'ospedale, scegliendo per il tempio sacro il medesimo rapporto volumetrico già in essere negli edifici attigui ed impiegando nella decorazione l'ordine tuscanico, semplice e lineare. Osservando la facciata si ha conferma immediata della linearità quasi manierista dell'architettura; il fronte è coronato da un massiccio cornicione in facciavista sagramata, sorretto da quattro paraste poggianti su di un secondo cornicione posto a divisione dei due volumi del prospetto. Quattro paraste, anch'esse sagramate e addossate ai pilastri del portico, sostengono la trabeazione tuscanica decorata con triglifi alternati a rettangoli vuoti e, al tempo stesso, dettano il ritmo a tutta la facciata. Tra le arcate del portico, trovano ancor oggi posto cinque paracarri di marmo, acquistati nel dicembre del 1750 dal priore Antonio Cattania per abbellire il fronte su via Santa Maria ed impedire il libero accesso al porticato55. Con l'arrivo in città, nella primavera del 1735, di un contingente di truppe francesi alleate dell'esercito estense, la chiesa fu adibita a magazzino, costringendo i confratelli ad allestire una cappella provvisoria nella camera delle Congregazioni. Certo che l'occupazione della chiesa non sarebbe durata a lungo, nell'agosto dello stesso anno, il priore Vincenzo Gianotti commissionò a sue spese, al modenese Gian Domenico Traeri, la costruzione di un nuovo organo da porre nella cantoria della chiesa56. Ad ottobre, col perdurare dell'acquartieramento dei soldati in Santa Maria, il priore decise di far costruire, nella Camera delle Congregazioni, un altare in muratura. Del disegno fu incaricato l'architetto correggese Giorgio Magnanimi (1682-1775), allievo del Bibbiena, mentre per la realizzazione ci si avvalse del mastro scagliolista Pietro Bardi57. (Figura 1.13)
54 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 44. Dal rogito apprendiamo che la casa, ancor oggi esistente, era posta in Correggio annessa a detto Hospitale a cui confina da una il medesimo Hospitale, dall'altra la via pubblica, dall'altra detto sig. Grillenzoni, e dall'altra il sig. canceliere Nicolò Carisi.
55 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43.
56 ibidem. Nel contratto si stabiliva che l'organo dovesse essere simile (per dimensioni e foggia) a quello della chiesa delle Monache di Santa Chiara, realizzato, nel 1719, dallo stesso Traeri per la soppressa confraternita della Trinità. In seguito della soppressione della confraternita di Santa Maria (1782) l'organo fu posto all'asta; acquistato dai Padri Domenicani fu trasferito nella chiesa di Madonna della Rosa. Stando alla testimonianza diretta del cav. Medoro Ligabue, organista da oltre sessant'anni della Basilica Collegiata di San Quirino in Correggio, l'organo Traeri, benché smontato e non più funzionante, rimase in Madonna della Rosa fino agli anni Quaranta del Novecento, per poi sparire nel dopoguerra. Ad oggi non sappiamo dove sia stato trasferito o da chi sia stato acquistato. Per quanto riguarda l'organo della soppressa confraternita della SS.ma Trinità, nel 1720, passò assieme alla chiesa alle Monache di Santa Chiara. Da queste fu venduto, sul finire del Settecento, alla parrocchiale di Mandriolo, dove ancor oggi lo si può ammirare nella cantoria in controfacciata. Maggiori notizie su questo strumento sono raccolte nel puntuale studio condotto da Sauro Rodolfi e Andrea Plichero, intitolato L'organo Domenico Traeri (1719) e le campane della chiesa di Mandriolo, edito a cura dalla stessa parrocchia nel dicembre del 2000.
57 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43.
L'occupazione della chiesa cessò solamente nel febbraio del 1738, lasciando pesanti danni agli altari e al pavimento della chiesa58. Dal 1756 al 1758, tutto il complesso dell'ospitale fu interessato da un nuovo grande intervento di restauro, finalizzato a ridonare funzionalità e "prestigio" alle vecchie strutture. Purtroppo i documenti non ci hanno tramandato il nome del progettista che fu incaricato di seguire i lavori, ma è probabile che i confratelli si rivolsero, ancora una volta, alla valida opera del Magnanini. Nello specifico i lavori coinvolsero il cortile, lo scalone e tutti gli ambienti del primo piano dell'ospitale, compresa la camera delle Congregazioni che fu alzata e coperta con una nuova volta a padiglione in muratura, così da adattarla alla volumetria della cantoria59. Nell'estate del 1761 fu intrapreso il restauro della sagrestia e del presbiterio, seguito dal tinteggio e dalla decorazione dei nuovi ambienti e rifatto gran parte del selciato in cotto della chiesa60. La decorazione dei nuovi ambienti fu affidata a Francesco Cipriano Forti (1713-1779) che dal 1768 al 1772, a più riprese, dipinse a chiaroscuro tutta la Camera delle Congregazioni e diversi mobili dell'ospitale61. Nel luglio del 1771 fu intonacata la facciata della chiesa e risistemata quella dell'ospitale. I lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato sono documentati fino a pochi mesi prima della soppressione della confraternita, così come ci è pervenuto un puntuale elenco dell'asta con la quale furono alienate tutte le suppellettili della chiesa, compresa la tela dei Quattro Santi del Correggio62. Avendo perduto con la sciagurata "vendita di Dresda" tutte le opere dell'Allegri presenti nella Galleria Ducale, nel 1786, Ercole III d'Este decise di fare asportare dal suo altare l'affresco della Madonna dei limoni e di trasferirlo a Modena. In soli due anni la città vide scomparire le ultime due opere del Correggio superstiti. Per oltre un decennio la chiesa di Santa Maria fu ridotta a magazzino e solo nell'ottobre del 1795, grazie all'intervento di un gruppo di devoti fu possibile riaprire al culto l'edificio, benché avesse subito pesanti danni dalle spogliazioni e la completa demolizione degli antichi altari63. L'unione di devoti incaricò l'architetto Filippo Cattania (1753-1813), di dirigere il restauro e già nel mese di novembre iniziarono i lavori. Fu dapprima rifatto il selciato della chiesa, sostituendo il vecchio pavimento in cotto con un battuto alla
58 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 43. All'indomani della riapertura della chiesa furono approntanti diversi lavori di restauro che interessarono oltre al selciato interno e del sottoportico, il rifacimento di molti altari della chiesa e il restauro dell'ancona dorata della cappella maggiore.
59 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 46, II registro, Memoria sulle origini di Santa Maria.
60 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 44.
61 ibidem.
62 Archivio Opere Pie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 65, busta III, Congregazione generale dei luoghi Pii. Atti di protocollo (1781-1784). Notifica della soppressione della confraternita di Santa Maria della Misericordia e inventario dei beni; rogito datato 27 settembre 1782.
63 Archivio Memorie Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 86.
veneziana64, poi si diede inizi la costruzione del nuovo altare maggiore, portata a termine entro il marzo del 1796. (Figura 1.14) Il mese successivo fu montata la nuova balaustra in ferro del presbiterio e iniziati i lavori per costruire l'altare laterale destro, dedicato alle Anime del Purgatorio65. Ad agosto fu terminato il pavimento del sottoportico e il nuovo altare del Crocifisso, posto nel mezzo della parete sinistra, dove sorgeva l'antico66. Dell'antico apparato liturgico di Santa Maria furono recuperate poche cose, tra queste alcune tele di modeste dimensioni e il grande Gonfalone processionale acquistato, all'indomani della soppressione della confraternita, da una famiglia legata al sodalizio. Non potendo recuperare l'originario organo Traeri, nel giugno del 1797, Francesco Timolini presidente della Pia Unione, decise di acquistare dal parroco di Bagnolo in Piano un antico organo positivo e di collocarlo sulla cantoria della chiesa67. Decaduto l'utilizzo della Gonfalone come stendardo, i responsabili della Pia Unione decisero di riadattarlo come "velario" della statua. Fu costruita, dietro l'ancona dell'altare, una macchina scenica che consentisse all'occorrenza di calare a scomparsa il quadro, scoprendo, in concomitanza con particolari festività liturgiche, la sottostante nicchia con il simulacro della Madonna. Per oltre un ventennio la chiesa non subì rilevanti modifiche e solo nel 1833, fu innalzata la nuova torre campanaria, coperta da una cupola in rame dal modenese Reggiani68. Nel 1837 fu nuovamente riparato il pavimento della chiesa e su perizia dell'architetto Francesco Forti (1801-1864), fu affidata per cottimo la ricostruzione degli ampi tetti del caseggiato al mastro
64 Archivio Memorie Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 154, Memorie (1794 -1823) di Pietro Vellani, alle date suddette. L'impresa esecutrice dei lavori di pavimentazione della chiesa era di proprietà del mastro muratore Luigi Scaltriti, esperto realizzatore di battuti veneziani. La stessa impresa aveva realizzato alcuni anni prima il nuovo pavimento della chiesa di San Francesco e sempre alle dipendenze di Cattania, nel 1788, quello del nuovo Palazzo Comunale.
65 Archivio Memoria Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 86. In una nota delle spese fatte per la costruzione dei tre nuovi altari, stilata dal presidente della Pia Unione, Francesco Timolini, leggiamo che gli altari furono tutti disegnati da Filippo Cattania e realizzati per la parte muraria dal muratore Pietro Riccò, mentre il decoro a stucco fu opera del correggese Antonio Guidetti detto Picchiotti. La nota è preziosa non solo perché conferma che tutte le maestranze impiegate nei lavori di restauro fossero di provenienza locale, quanto più perché fornisce un elenco puntuale di tutti i materiali occorsi, della quantità impiegata e della provenienza, fondamentali per sviluppare le ipotesi di restauro del complesso architettonico.
66 ibidem. Dalle "Memorie" di Pietro Vellani apprendiamo che la costruzione del nuovo altare del Crocifisso fu iniziato il 21 dicembre del 1795 ad opera del muratore Pietro Riccò ma a causa di una sua malattia i lavori alla chiesa si protrassero per molti mesi.
67 Archivio Memoria Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 154, Memorie (1794 -1823) di Pietro Vellani, alle date suddette e Archivio Memoria Patrie, Biblioteca comunale di Correggio, cartella 86. Si tratta di un magnifico organo positivo degli inizi del Seicento, con facciata lignea intagliata a cinque campate. Francesco Timoli, presidente della Pia Unione, lo acquistò da don Pietro Lusuardi, parroco di Bagnolo per la cifra di £ 1033.15 corrispondenti a circa 23 zecchini reggiani. Pietro Vellani, nella sua Cronaca, riporta che fu chiamato ad accordarlo Quirino Asioli, organaro e orologiaio correggese, il quale lo reputò un eccellente strumento. L'organo è oggi conservato nella Basilica di San Quirino.
68 Cenni storici intorno alla Chiesa e Pia unione di S. Maria della Misericordia, Modena tip. Antonio Angelo Cappelli. Opuscolo a stampa edito dalla Pia Unione di Santa Maria della Misericordia nel 1859, a conclusione dei lavori di ristrutturazione del complesso. A pagina 8 è riportato il nome del mastro artigiano autore della cupola in rame del nuovo campanile.
muratore Angelo Diacci69. In occasione della proclamazione di Papa Pio IX del dogma dell'Immacolata Concezione (1854), tutto l'apparato decorativo interno ed esterno della chiesa fu rinnovato dal pittore Andrea Capretti (1821-1870c.), su progetto dall'architetto Forti, al quale fu affidato il ridisegno della facciata settentrionale della chiesa70. L'intervento di Forti comportò la trasformazione del fianco di Santa Maria in forme neogotiche eclettiche: furono rivestite con finte bifore le finestre settecentesche della navata, applicati finti contrafforti e realizzata, come fascia marcapiano del sottotetto, una "frappa" ad archetti gotici. Il carattere goticheggiante del prospetto fu accentuato dalla decorazione geometrica a chiaroscuro realizzata dal Capretti, purtroppo oggi completamente perduta. All'interno, Capretti decise di seguire lo stile neoclassico piranesiano già impiegato da Filippo Cattania nel comporre gli altari, Cinquant'anni prima; con grande maestria reinterpretò le volute e i festoni delle ancone, realizzando la decorazione a chiaroscuro delle cinquecentesche volte a crociera giocando con toni grigio, verdi e rosacei. Le pareti furono incorniciate da fasce geometriche a chiaroscuro, impreziosite, nelle parti libere, da finte nicchie ospitanti le immagini dei santi titolari degli antichi altari della chiesa. Di maggior gusto eclettico risulta la decorazione del presbiterio dove le pareti sono decorate a finto damasco blu su fondo ocra, mentre la volta tetrapartita riporta allegorie mariane,derivanti dalle litanie lauretane. L'archivolto del presbiterio è adornato da due grandi festoni classicheggianti, con foglie d'acanto e di palma intrecciate fra di esse, sormontato al centro da un cartiglio in chiaroscuro, recante un motto mariano. Similmente furono decorati tutti gl'archivolti della chiesa, creando un elegante ritmo di ascesi verso l'altare maggiore. La forte umidità di risalita e i danni provocati dai terremoti del 1996 e del 2000, hanno in più parti rovinato l'opera del Capretti, senza però cancellarne il carattere fantasioso e fortemente romantico, prerogative dell'arte decorativa dell'epoca. Sul finire degli anni Settanta del secolo scorso furono eseguiti un serie di interventi di restauro non filologici71 che alterarono la staticità dell'edificio aumentando il degrado della chiesa, diventato drammatico dopo i citati sismi che hanno provocato il lesionamento di molte parti strutturali e causato il parziale crollo della volta della camera della Congiura.
4.1 Soglie storiche costruttive
69 ibidem.
70 ibidem. Nella memoria, densa di particolari di colore e di cronaca, si riporta anche il nome del mastro muratore che venne chiamato ad eseguire il progetto di Forti, tale Geminiano Marchi, attivo in quegli anni in Correggio con una piccola impresa edile.
71 Autore dell'intervento di restauro, che ottenne l'autorizzazione dell'allora Soprintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, architetto Germana Aprato, fu l'ingegnere Riccardo Bigi di Reggio nell'Emilia.
Inquadramento storico
I numerosi interventi di ampliamento o rifacimento del complesso, succedutisi nel corso dei secoli, hanno richiesto l'elaborazione di un attento studio archivistico che ha consentito di ricostruire la storia del fabbricato, raccolta all'interno della relazione storica.
Di seguito si riporta l'elenco, per soglie storiche, delle principali modifiche subite dal complesso architettonico di Santa Maria della Misericordia:
1. luglio 1439: dalla relazione allegata alla visita pastorale Fogliani emerge che la confraternita dispone di una chiesa, contigua all'ospedale, dotata di tutte le suppellettili liturgiche al pari della altre chiese cittadine.
2. 1465: vengono costruite, al piano superiore dell'ospitale, due nuove camere dotate ciascuna di quattro letti e di due armadi.
3. 1490: riedificazione della chiesa di Santa Maria della Misericordia. L'intervento di ampliamento dell'edificio si protrarrà, a fasi alterne, per oltre un ventennio interessando anche il complesso dell'ospitale. La prima fase dei lavori è molto celere, tanto da consentire al vescovo di Reggio, monsignor Bonfrancesco Arlotti, di consacrare la nuova chiesa il 3 ottobre del 1491.
4. 1494: i confratelli acquistano quattro colonne di marmo per sostenere il nuovo porticato della facciata. Differentemente dall'attuale, il prospetto si presentava arretrato rispetto all'ospitale, con il fronte a capanna e una finestra circolare nel centro della facciata.
5. 1501: sono ultimati i lavori alla nuova sagrestia, ricavata nel vano dietro all'altare maggiore, dove ancora oggi si trova.
6. 1513: sono portate a termine le volte a crociera della chiesa. La tecnica costruttiva impiegata in Santa Maria, già in uso nella Correggio del tardo Quattrocento, prevede la realizzazione di volte a doppia camicia di muratura, con costoloni e rinfianco interno.
7. 1522-23: la confraternita fa erigere la nuova ancona dell'altare maggiore per inserire attorno alla quattrocentesca scultura della Madonna della Misericordia, le tre tele del Correggio componenti il Trittico della Misericordia divina .
8. 1573: i confratelli della Misericordia acquistano la casa confinante con l'ospitale, prospiciente su via Santa Maria. L'edificio, tuttora esistente, dal 1782 non fa più parte del complesso dell'ospitale.
9. 1575: per fare fronte alla crescente richiesta di ospitalità, viene acquistata anche la casa attigua alla precedente. L'edificio, tuttora esistente, dal 1782 non fa più parte del complesso dell'ospitale.
10. 1619: viene rifatto il presbiterio e risistemato il pavimento in cotto della chiesa.
11. 1699: la confraternita acquista un'altra casa, posta dietro la sagrestia. L'edificio, tuttora esistente, dal 1782 non fa più parte del complesso dell'ospitale.
12. 1695 - 1700: in questi anni è edificata la nuova facciata della chiesa di Santa Maria. L'antico portico in colonne di pietra è sostituito da una più solida struttura in muratura, composta da pilastri quadrangolari e volte a crociera a sostegno di un'ampia cantoria.
13. 1704: dalla relazione redatta in occasione della visita pastorale Picenardi si apprende che la chiesa, da oltre un secolo, era dotata di sette altari, ricavati all'interno del perimetro della chiesa ad eccezione del vano del presbiterio.
14. 1738: ha temine dopo quasi tre anni l'occupazione della chiesa da parte delle truppe francesi, lasciando pesanti danni agli altari e al pavimento. Furono approntanti diversi lavori di restauro che interessarono oltre al selciato interno e del sottoportico, il completo rifacimento di molti gli altari della chiesa tra i quali gran parte della cappella maggiore.
15. 1756 - 1758: tutto il complesso dell'ospitale è interessato da un nuovo grande intervento di restauro, finalizzato a ridonare funzionalità e "prestigio" alle vecchie strutture. L'autore dell'intervento è, probabilmente, l'architetto correggese Giorgio Magnanimi (1682-1775), allievo del Bibbiena.
16. 1761: si interviene sulle murature della sagrestia e della crociera del presbiterio. Tutti i nuovi ambienti vengono tinteggiati e decorati. Il selciato in cotto della chiesa viene rifatto interamente.
17. 1768- 1772: all'architetto Francesco Cipriano Forti (1713-1779) è affidato il completamento dei lavori di decorazione della sala delle Congregazioni e delle altre parti dell'ospitale.
18. 1771: viene rifatto l'intonaco della facciata della chiesa e risistemato il prospetto dell'ospitale su via Santa Maria.
19. settembre 1782: a seguito della soppressione della confraternita la chiesa e l'ospitale passano alla Congregazione di Carità di Correggio. La chiesa privata degli arredi sacri e degli altari è destinata a magazzino. L'ospitale, ridotto al solo nucleo originario, è chiuso e dato in affitto come privata abitazione.
20. 1795: grazie all'interessamento di un gruppo di devoti, nel mese di marzo iniziano i lavori di restauro della chiesa di Santa Maria. L'architetto correggese Filippo Cattania (1753-1813), è incaricato di dirigere il restauro che prevede la ricostruzione dell'altare maggiore e di due altari laterali posti nella seconda campata. Il vecchio pavimento in cotto del portico e della chiesa è sostituito da un battuto alla veneziana. Il 24 dicembre del 1796, il canonico Corrado Corradi, arciprete della collegiata di San Quirino, benedice solennemente la chiesa riaperta.
21. 1833: viene innalzata la nuova torre campanaria, coperta da una cupola in rame dal modenese Reggiani.
22. 1854: l'intero apparato decorativo interno ed esterno della chiesa è rinnovato dal pittore Andrea Capretti (1821-1870c.); all'architetto Forti, è affidato il ridisegno della facciata settentrionale della chiesa.
23. 1979: dopo anni di abbandono l'ingegnere Riccardo Bigi, per conto della parrocchia di San Quirino (succeduta alla pia unione nella proprietaria dell'immobile), progetta un intervento di rifacimento di consolidamento e deumidificazione della chiesa. Viene sostituita la copertura lignea con un tetto in latero-cemento sostenuto da 5 capriate metalliche triangolari ancorate a due cordoli in calcestruzzo armato. L'edificio viene sottoposto a "taglio meccanico"per bloccare l'umidità di risalita.
24. 1985: per bloccare l'umidità di risalita, l'edificio viene sottoposto a "taglio meccanico" delle murature; contestualmente viene rifatto il pavimento della chiesa sostituendo il battuto veneziano, completamente deteriorato dall'umidità, con una pavimentazione in cotto. L'intonaco esterno della chiesa, del sotto portico e delle parti interne alla chiesa ammalorate viene rifatto con malta bastarda (calce, cemento e sabbia).
25. 1996: a seguito del forte sisma del 15 ottobre, il complesso di santa Maria subisce notevoli danni tra i quali il parziale crollo della settecentesca volta della sala delle Congregazioni e il lesionamento delle logge interne del cortile e di una parte delle volte della chiesa. L'edificio viene puntellato nelle parti maggiormente danneggiate.
26. 2000: il 18 giugno un nuovo sisma, aggrava la situazione strutturale dell'edificio. Il Comune di Correggio con ordinanza del 21/06/2000, ordina l'immediata esecuzione di lavori di messa in sicurezza dell'immobile. La parrocchia di San Quirino, proprietaria dell'immobile, incarica lo studio Associato Gasparini di Reggio Emilia di progettare un primo intervento di consolidamento strutturale del portico di via Santa Maria. L'ingegnere Stefano Teneggiani esegue un intervento di cuci scuci all'estradosso delle volte completato da una cappa strutturale in conglomerato armato.
27. 2008: un nuovo sisma, di bassa entità, colpisce il 23 dicembre la provincia reggiana. Nella chiesa e nell'ospitale si aggravano alcune situazioni strutturali già compromesse dai precedenti terremoti. Il comune di Correggio con ordinanza del 30/12/2008 ordina di provvedere a nuovi lavori di messa in sicurezza dell'immobile. L'ingegnere Corrado Prandi di Correggio è incaricato dalla parrocchia di San Quirino di provvedere alla messa in sicurezza della chiesa. Viene puntellato l'archivolto del presbiterio e rinforzato l'appoggio di un setto murario in corrispondenza del portico.